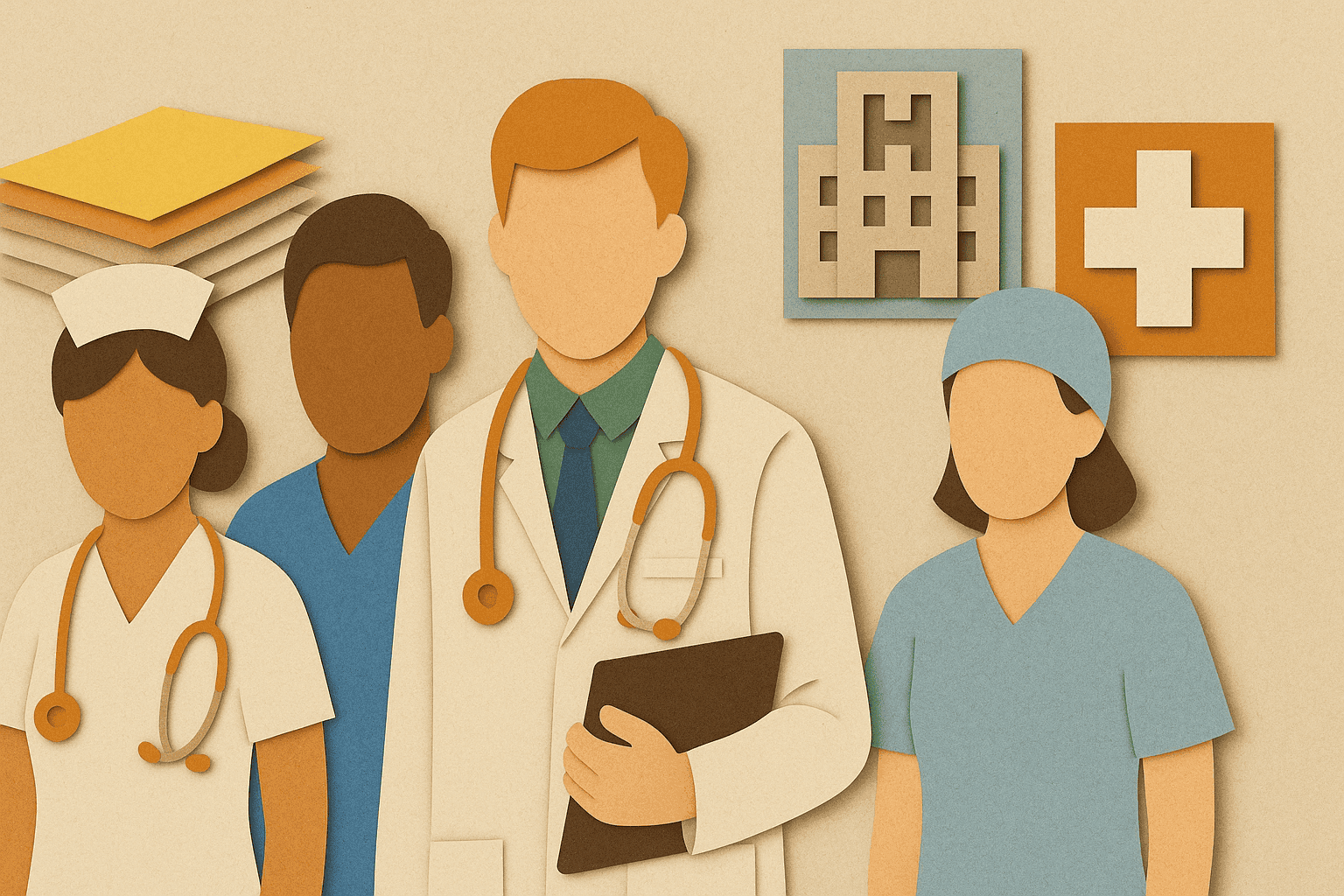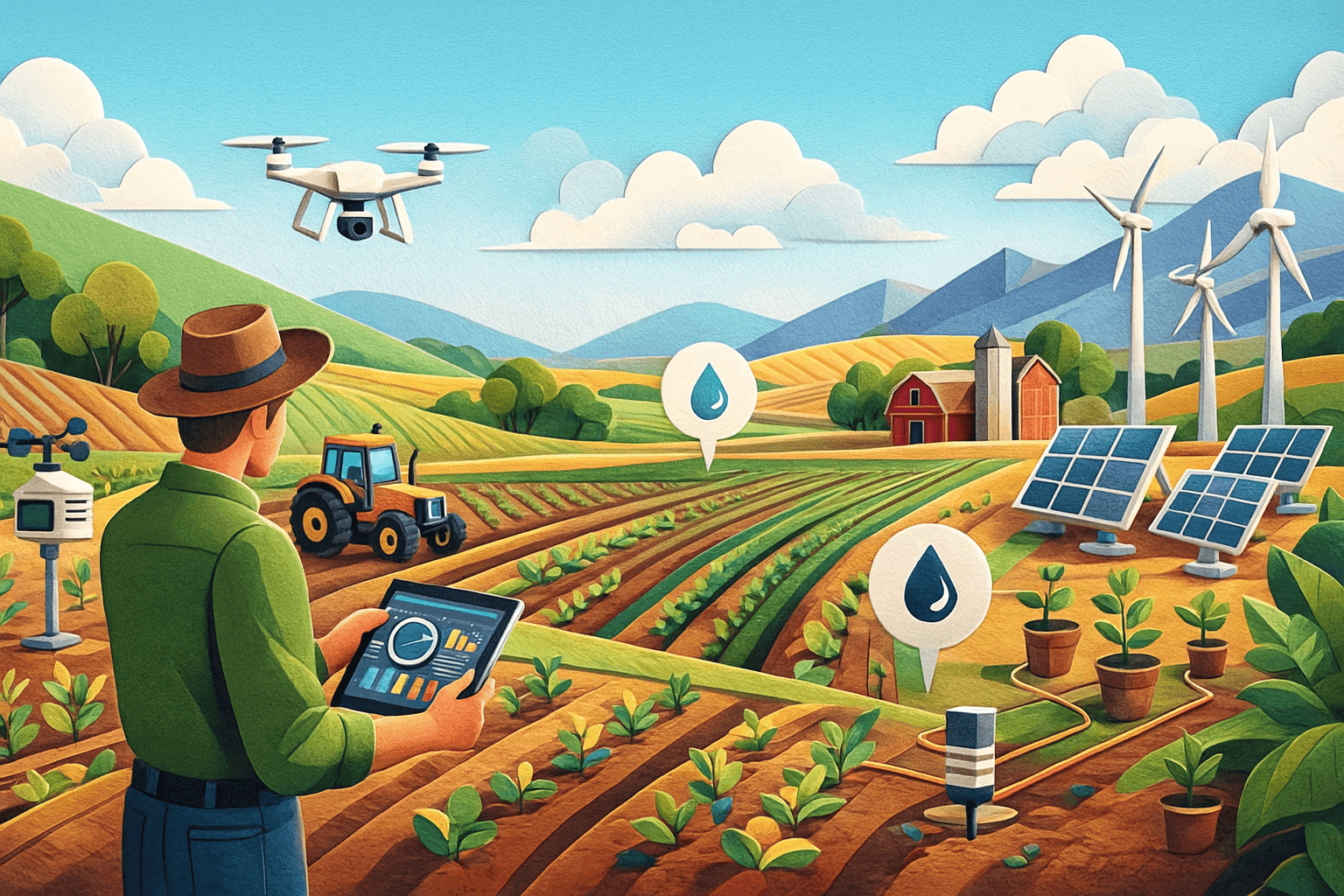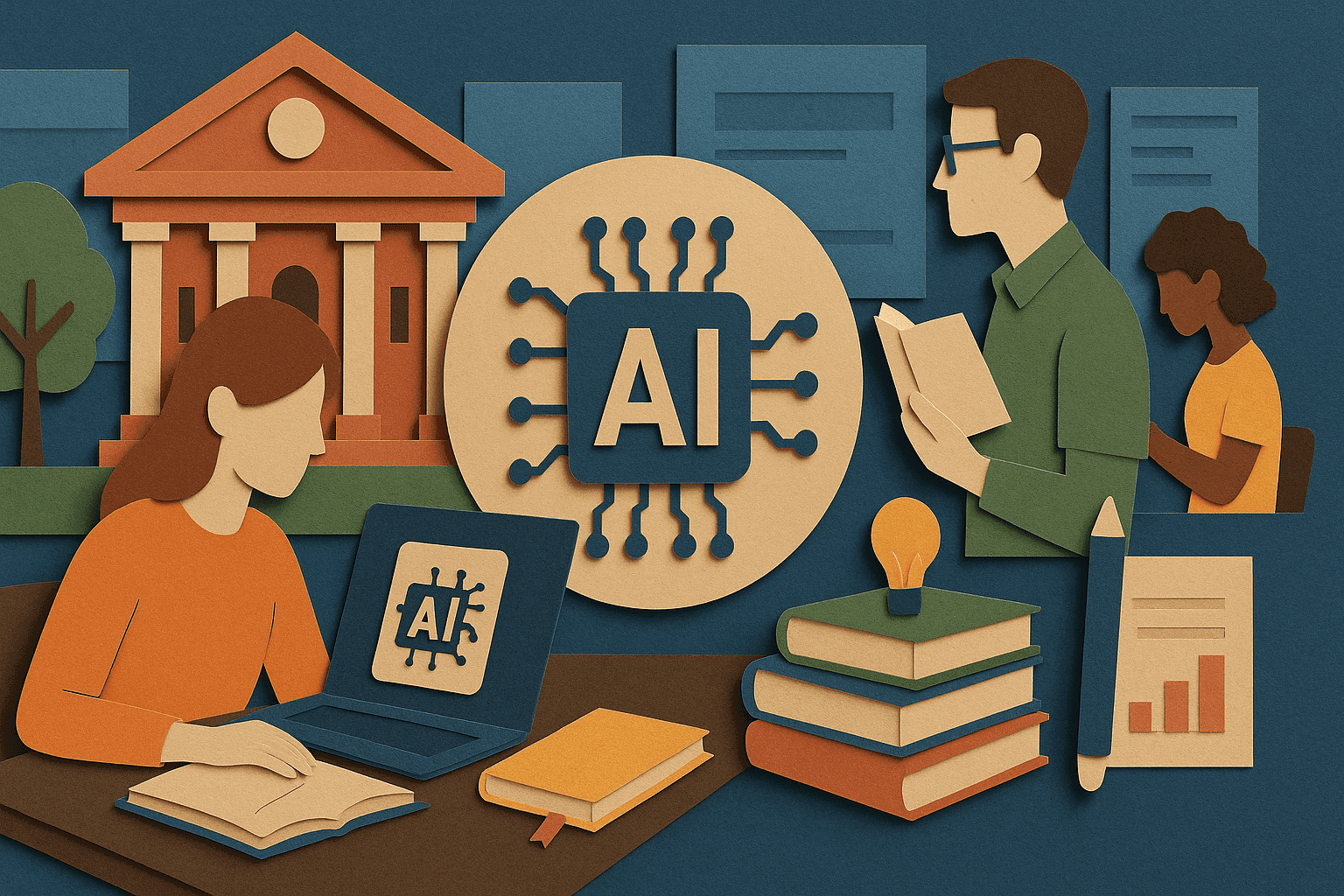Ogni autunno, la pubblicazione della Times Higher Education World University Rankings segna un passaggio atteso nel mondo accademico. È un momento in cui migliaia di università — e milioni di studenti — scoprono come cambia la mappa globale della conoscenza.
La classifica, tra le più influenti al mondo, valuta la qualità complessiva degli atenei più orientati alla ricerca. Per farlo, mette insieme numeri e percezioni, analizzando:
- la didattica, cioè l’ambiente in cui si forma la prossima generazione di ricercatori;
- la produzione scientifica, misurata attraverso milioni di pubblicazioni e citazioni;
- la reputazione accademica, basata su sondaggi tra docenti e studiosi;
- l’impatto sull’industria e il mondo del lavoro;
- l’apertura internazionale, con studenti, collaborazioni e docenti da tutto il mondo.
L’edizione 2026, pubblicata nell’ottobre 2025, prende in esame 2.191 università di 115 Paesi. Dietro ai punteggi ci sono oltre 108.000 risposte al sondaggio accademico e più di 16 milioni di articoli scientifici analizzati. In sostanza, una fotografia ampia e aggiornata di dove si fa la ricerca più influente, dove cresce la qualità della formazione e come gli atenei reagiscono alle grandi sfide globali — dalla digitalizzazione alla sostenibilità, fino alla competizione per attrarre talenti.
A differenza di altre classifiche (come QS o Shanghai ARWU), Times Higher Education (che si può consultare integralmente qui) non valuta singoli corsi o dipartimenti: guarda all’università nel suo insieme, come ecosistema fatto di persone, risorse, risultati e visione.
Una bussola per studenti, ricercatori e governi
Il valore di questa classifica non è solo simbolico. Per studenti e famiglie, serve da orientamento nelle scelte di studio internazionale. Per ricercatori e policy maker, rappresenta una metrica di reputazione e di attrattività: un modo per capire quali università attraggono fondi, partnership e talenti, e quali stanno migliorando nei propri ambiti. Per i governi, infine, il THE Ranking è anche uno strumento di analisi comparativa: misura la “forza accademica” di un Paese, in un mondo in cui la conoscenza è ormai un indicatore di potere geopolitico.
La metodologia 2026: cinque pilastri, diciotto indicatori
Dal 2024 Times Higher Education utilizza la nuova metodologia “WUR 3.0”, che ha reso più preciso il sistema di pesi e ha integrato nuovi parametri per misurare la qualità della ricerca, oltre alla semplice quantità di pubblicazioni.
Il modello si fonda su cinque grandi pilastri e diciotto indicatori ponderati:
| Pilastro | Descrizione sintetica | Peso complessivo |
|---|---|---|
| Teaching (Ambiente didattico) | Reputazione accademica, rapporto studenti/docenti, numero di dottorati, bilanci dedicati alla formazione. | 29,5% |
| Research Environment (Ambiente di ricerca) | Reputazione della ricerca, produttività scientifica e finanziamenti. | 29,0% |
| Research Quality (Qualità della ricerca) | Citazioni, influenza e impatto della ricerca misurato su scala globale. | 30,0% |
| International Outlook (Prospettiva internazionale) | Percentuali di studenti e personale straniero, co-autorship con istituzioni estere. | 7,5% |
| Industry (Entrate dal settore produttivo) | Fondi e collaborazioni con l’industria, trasferimento tecnologico, brevetti. | 4,0% |
A questi pilastri si aggiungono 18 sotto-indicatori. Tra i principali:
- reputazione dell’insegnamento (15%)
- rapporto studenti/docenti (4,5%)
- citazioni e influenza scientifica (15%)
- collaborazioni internazionali nelle pubblicazioni (5%)
- entrate da partnership industriali (4%)
I dati bibliometrici provengono da Elsevier–Scopus, considerando pubblicazioni tra il 2020 e il 2024 e citazioni fino al 2025. Le informazioni reputazionali, invece, derivano dal THE Academic Reputation Survey, condotto su scala mondiale tra la primavera 2024 e il 2025.
Criteri di inclusione e trasparenza dei dati
Per essere incluse nella classifica, le università devono soddisfare tre condizioni:
- pubblicare almeno 1.000 articoli scientifici in cinque anni;
- offrire un’offerta formativa completa (non solo scuole specialistiche);
- disporre di dati verificabili e comparabili su studenti, personale e bilanci.
Le università che non forniscono dati completi o non raggiungono la soglia minima vengono indicate come “reporters”, cioè presenti ma non classificate. Questo approccio rende il ranking THE una delle classifiche più trasparenti e verificabili del panorama globale.
Le migliori università del mondo nel 2026
Nel 2026, la vetta della classifica Times Higher Education non cambia: Oxford resta al primo posto per il decimo anno consecutivo, confermandosi il punto di riferimento mondiale per la qualità della ricerca e la solidità del sistema accademico britannico.
Top-10 mondiale THE 2026
1 – University of Oxford (Regno Unito)
2 -Massachusetts Institute of Technology (MIT) – Stati Uniti
3 – University of Cambridge – Regno Unito e Princeton University – Stati Uniti (ex aequo)
5 – Harvard University – Stati Uniti e Stanford University – Stati Uniti (ex aequo)
7 – California Institute of Technology (Caltech) – Stati Uniti
8 – Imperial College London – Regno Unito
9 – University of California, Berkeley – Stati Uniti
10 – Yale University – Stati Uniti
La Top-10 è quasi immutata rispetto al 2025. Dominano Regno Unito e Stati Uniti, con otto atenei americani e due britannici ai vertici. È la fotografia di un’élite accademica che, pur sotto pressione, continua a concentrare le risorse scientifiche e la reputazione globale.
Tendenze globali: tra stabilità e nuovi equilibri
La classifica Times Higher Education 2026 racconta un panorama accademico mondiale che si muove con lentezza, ma in direzioni sempre più definite. Il vertice, come abbiamo visto, resta dominato da Stati Uniti e Regno Unito, ma emergono segnali di riequilibrio: la crescita asiatica rallenta, l’Australia risale, e in Europa si rafforzano le differenze interne tra i sistemi universitari nazionali. Il risultato è una mappa in cui la stabilità dell’élite globale convive con la mobilità di molte aree intermedie, che guadagnano terreno nei pilastri della ricerca e dell’internazionalizzazione.
Stati Uniti: primato stabile, ma meno diffuso
Le università statunitensi restano predominanti nella fascia alta della classifica, ma perdono posizioni nel resto della Top-100. Il motivo è duplice: da un lato, la crescente concorrenza di Paesi che investono di più nella ricerca pubblica; dall’altro, le difficoltà strutturali di molti campus americani, tra calo delle immatricolazioni e pressioni sui costi di iscrizione. Harvard, MIT e Stanford restano saldamente nella Top-5, ma altri atenei — come Chicago, Columbia e Penn — scivolano di qualche posizione.
Regno Unito: Oxford resiste, Cambridge tallona
L’Università di Oxford mantiene la leadership mondiale grazie all’eccellenza nella ricerca interdisciplinare e alla solidità del modello collegiale. Cambridge, seconda europea, consolida la terza posizione ex aequo con Princeton, mentre l’Imperial College London rientra nella Top-10 dopo un anno di assenza, segno della forte ripresa delle università britanniche nei settori STEM. Tuttavia, nel complesso il Regno Unito vede un leggero calo di performance tra le università medie, penalizzate da incertezze sui finanziamenti post-Brexit.
Asia: crescita che rallenta
Per la prima volta dopo anni di ascesa costante, la regione asiatica mostra una stabilizzazione ai vertici. Le cinesi Tsinghua University e Peking University restano solide nella Top-20, ma non guadagnano terreno. Singapore, con la National University of Singapore (NUS), si conferma la più alta in classifica tra le università del Sud-Est asiatico, mentre Hong Kong e Corea del Sud continuano a migliorare nel pilastro dell’internazionalizzazione. Il trend è chiaro: la crescita quantitativa si è fermata, ma la qualità media resta alta e più diffusa che in passato.
Australia: la sorpresa del 2026
L’Australia è uno dei pochi Paesi a registrare un miglioramento diffuso. L’Università di Melbourne sale al 37° posto, seguita da Sydney e Monash, entrambe in crescita. Il successo è legato a un modello accademico che combina forte internazionalizzazione e ricerca applicata, con investimenti pubblici mirati su tecnologie verdi e intelligenza artificiale. Dopo anni di difficoltà dovute alla chiusura dei confini e alla crisi del turismo studentesco, gli atenei australiani tornano a crescere anche in reputazione.
Europa continentale: il blocco tedesco in tenuta, Francia in recupero
La Germania mantiene una buona presenza tra le prime 100, con LMU München e TU München stabili nei primi 50 posti. In Francia, PSL (Paris Sciences et Lettres) e Sorbonne Université registrano progressi dopo le riforme di governance universitaria e il rafforzamento dei programmi di ricerca congiunti. La Spagna resta invece marginale, pur mostrando segnali di miglioramento sul fronte internazionale.
Un’élite globale sempre più selettiva
In sintesi, la classifica 2026 conferma una realtà ormai consolidata:
- L’élite mondiale si restringe, ma si rafforza nei suoi equilibri storici.
- Le università anglosassoni continuano a dominare per risorse e influenza scientifica.
- Le economie emergenti puntano sull’internazionalizzazione e sulla collaborazione industriale per colmare il divario.
Il baricentro del sapere globale, almeno per ora, resta saldo tra Stati Uniti, Regno Unito e Asia orientale — ma le tendenze mostrano che la prossima grande rivoluzione accademica potrebbe arrivare proprio dalle regioni oggi in rimonta.
Le università italiane nella classifica Times Higher Education 2026
Nel 2026 l’Italia consolida la propria presenza nella classifica mondiale Times Higher Education, con risultati in crescita per diversi atenei. In totale, oltre 50 università italiane sono incluse nel ranking, ma solo tre entrano nella Top 200, segno di un sistema in miglioramento ma ancora lontano dai vertici globali.
| Posizione / fascia | Ateneo | Note salienti |
|---|---|---|
| 130 | Università di Bologna | Prima italiana, in crescita rispetto al 146° posto del 2025. |
| 137 | Scuola Normale Superiore di Pisa | Migliora sensibilmente, solida nella ricerca di base. |
| 170 | Sapienza – Università di Roma | Entra nella Top 200 con performance in aumento. |
| 201–250 | Politecnico di Milano | Ottima reputazione internazionale e risultati costanti. |
| 201–250 | Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa | Forte nel rapporto industria-ricerca. |
| 201–250 | Università di Padova | Consolidata tra le migliori italiane per ricerca e pubblicazioni. |
| 251–300 | Humanitas University | Migliora nel pilastro Research Quality. |
| 251–300 | Università Cattolica del Sacro Cuore | Buoni risultati in teaching e reputation. |
| 251–300 | Università Vita-Salute San Raffaele | Eccellenza nel biomedicale e nella ricerca clinica. |
| 301–350 | Università di Milano | Solida crescita nella ricerca internazionale. |
| 301–350 | Università di Napoli Federico II | Migliora nei parametri di didattica e produzione scientifica. |
| 301–350 | Università di Roma Tor Vergata | In ascesa grazie a collaborazioni internazionali. |
| 351–400 | Università di Brescia | Si distingue in ambito medico e tecnologico. |
| 351–400 | Università di Firenze | Buoni risultati nella qualità della ricerca. |
| 351–400 | Università di Pavia | Tradizione di ricerca e formazione di alto livello. |
| 351–400 | Università di Pisa | Migliora leggermente nella reputazione accademica. |
| 351–400 | Università di Siena | Stabile nel ranking, buona performance in didattica. |
| 351–400 | Università di Trento | Cresce per internazionalizzazione e collaborazione UE. |
| 351–400 | Università di Verona | In progresso costante negli indicatori di ricerca. |
| 401–500 | Libera Università di Bolzano | Internazionalizzazione e ricerca applicata in crescita. |
| 401–500 | Politecnico delle Marche | Migliora nei rapporti con l’industria. |
| 401–500 | Politecnico di Torino | Solida tradizione ingegneristica, stabile nella fascia. |
| 401–500 | Università di Genova | Buon andamento nella ricerca e nei progetti europei. |
| 401–500 | Università di Milano-Bicocca | Avanza nei parametri di didattica e pubblicazioni. |
| 401–500 | Università di Torino | In leggera crescita rispetto al 2025. |
| 501–600 | Università Ca’ Foscari di Venezia | Forte nei settori economici e umanistici. |
| 501–600 | Campus Bio-Medico di Roma | Buoni risultati nella ricerca biomedica. |
| 501–600 | Politecnico di Bari | Avanza nei progetti di ricerca applicata. |
| 501–600 | Università di Catania | Cresce nella produttività scientifica. |
| 501–600 | Università di Ferrara | Stabile, con buoni punteggi in teaching. |
| 501–600 | Università di Messina | Migliora leggermente nei parametri internazionali. |
| 501–600 | Università di Modena e Reggio Emilia | In progresso nella ricerca tecnologica. |
| 501–600 | Università di Palermo | Buone performance in citazioni e outreach. |
| 501–600 | Università di Salerno | Avanza nelle collaborazioni industriali. |
| 501–600 | Università di Trieste | In crescita nei progetti di ricerca europei. |
| 601–800 | Università del Piemonte Orientale “A. Avogadro” | In miglioramento nella produttività scientifica. |
| 601–800 | Università Parthenope di Napoli | Cresce nei parametri di didattica e outreach. |
| 601–800 | Università Aldo Moro di Bari | Stabile nella fascia, buona presenza internazionale. |
| 601–800 | Università di Cagliari | Migliora nei punteggi di teaching e industry. |
| 601–800 | Università della Calabria | Solida nella ricerca interdisciplinare. |
| 601–800 | Università dell’Insubria | In crescita per produttività scientifica. |
| 601–800 | Università dell’Aquila | Incrementa la collaborazione internazionale. |
| 601–800 | Università di Parma | Buoni risultati nella didattica e nei progetti UE. |
| 601–800 | Università della Tuscia | Rafforza la dimensione di ricerca applicata. |
| 601–800 | Università di Udine | Stabile nella fascia medio-alta. |
| 801–1000 | Università Gabriele D’Annunzio di Chieti-Pescara | Migliora nei parametri biomedici. |
| 801–1000 | Università di Foggia | Mantiene buoni risultati nel pilastro teaching. |
| 801–1000 | Università Roma Tre | Buone performance nella qualità della ricerca. |
| 801–1000 | Università del Salento | In leggera crescita per produttività scientifica. |
| 1001–1200 | Università Kore di Enna | Consolidata tra le giovani università italiane. |
| 1001–1200 | Università di Camerino | Buon andamento nella ricerca scientifica. |
| 1001–1200 | Università della Campania “Luigi Vanvitelli” | Cresce nella qualità della formazione. |
| 1001–1200 | Università del Sannio | In miglioramento nella produttività scientifica. |
| 1201–1500 | Università di Urbino “Carlo Bo” | Rientra nel ranking con buoni risultati nella didattica. |
Analisi e tendenze del sistema universitario italiano 2026
L’edizione 2026 della Times Higher Education World University Rankings segna un passo avanti per il sistema accademico italiano. Non solo per il primato confermato dell’Università di Bologna, ma soprattutto per la presenza più ampia e diffusa degli atenei italiani nelle varie fasce della classifica: da Nord a Sud, dalle università generaliste alle scuole di eccellenza, fino ai poli tecnici e alle realtà più giovani.
Un sistema più ampio e competitivo
Nel 2026, oltre 50 università italiane sono incluse nel ranking THE ed è la conferma che il sistema universitario nazionale, pur con risorse inferiori rispetto ad altri Paesi, sta guadagnando visibilità internazionale e qualità scientifica diffusa. La Top 200 resta dominata da tre atenei:
- Università di Bologna (#130), stabile al vertice italiano e in crescita costante;
- Scuola Normale Superiore di Pisa (#137), eccellente nella ricerca di base e nella formazione dottorale;
- Sapienza Università di Roma (#170), in consolidamento dopo anni di progressione graduale.
Subito dopo, si apre una fascia di atenei solidi e dinamici: Politecnico di Milano, Sant’Anna e Padova (tutti tra 201–250), seguiti da Humanitas, Cattolica e San Raffaele, che rappresentano il meglio della ricerca biomedica italiana.
Nord e Sud: un divario che si assottiglia
Il Mezzogiorno compare in modo significativo nelle fasce centrali della classifica. Università come Napoli Federico II, Parthenope, Salerno, Catania, Messina, Palermo e Bari (sia Aldo Moro sia Politecnico) si posizionano tra 300 e 600, segno di una ripresa lenta ma tangibile. È un risultato che riflette politiche di ricerca più mirate, la partecipazione a bandi europei e la valorizzazione di dottorati e infrastrutture condivise.
Le sfide strutturali restano
Nonostante i progressi, alcune criticità continuano a frenare l’ascesa complessiva del sistema:
- Internazionalizzazione: gli atenei italiani attraggono ancora pochi docenti e studenti stranieri rispetto alla media europea.
- Finanziamento della ricerca: la spesa pubblica e privata in R&D resta sotto la soglia OCSE, limitando la competitività nei pilastri Research Quality e Industry Income.
- Reputazione accademica: il “reputation survey” premia le università storiche e mediaticamente più visibili, un fattore che tende a penalizzare i nuovi poli italiani.
Come leggere (bene) le classifiche
Dietro ogni classifica ci sono numeri, ma anche interpretazioni. La Times Higher Education World University Rankings non è un verdetto assoluto: è uno strumento di lettura del sistema universitario globale. Capire come funziona — e come va interpretata — è il primo passo per usarla davvero in modo utile.
1. Guardare ai punteggi, non solo al posto in classifica
Il numero accanto al nome dell’università è la sintesi di decine di indicatori ponderati. Due atenei distanti dieci o venti posizioni possono avere punteggi quasi identici, separati da frazioni di punto.
Per questo, il rank da solo non racconta tutta la storia: conviene osservare anche i valori per ciascun pilastro (Teaching, Research, International Outlook, Industry) per capire dove un’università eccelle e dove può migliorare.
2. I contesti contano
Le classifiche globali mettono insieme sistemi accademici profondamente diversi:
- Paesi con investimenti pubblici molto diversi;
- sistemi di governance più o meno autonomi;
- mercati del lavoro e della ricerca eterogenei.
Un’università italiana, per esempio, compete in un contesto di finanziamenti pubblici più limitati rispetto a Stati Uniti o Regno Unito, ma può eccellere in altri aspetti, come la formazione scientifica o la qualità dei rapporti docenti/studenti. Le classifiche, dunque, non vanno lette come una gara diretta, ma come un termometro comparativo.
3. La reputazione pesa — ma non sempre misura la qualità
Oltre il 30% del punteggio totale deriva dal “reputation survey”, cioè dal giudizio espresso da accademici di tutto il mondo. È un indicatore potente ma anche fortemente cumulativo: le università con maggiore visibilità internazionale tendono a mantenere nel tempo un vantaggio reputazionale, indipendentemente dai risultati effettivi dell’anno. Per questo, le classifiche vanno integrate con altri dati oggettivi — come le pubblicazioni, le collaborazioni o i tassi di occupazione dei laureati.
4. THE, QS, Shanghai: differenze da conoscere
Non tutte le classifiche usano gli stessi criteri.
Ecco le principali differenze tra le tre più note:
| Classifica | Focus principale | Peso della reputazione | Note distintive |
|---|---|---|---|
| Times Higher Education (THE) | Ricerca, didattica, internazionalizzazione | ~33% | Valutazione istituzionale ampia; metodologia complessa e trasparente |
| QS World University Rankings | Reputazione e occupabilità | ~50% | Premia la percezione e i rapporti con i datori di lavoro |
| Shanghai Ranking (ARWU) | Produzione scientifica e premi Nobel | 0% | Interamente basata su indicatori oggettivi di ricerca |
Sapere quale classifica si sta leggendo aiuta a contestualizzare i risultati e a capire perché un’università può essere 150ª in THE ma 70ª in QS, o viceversa.
5. Come usare il ranking (davvero)
Per studenti, docenti e ricercatori, la classifica è una bussola, non una destinazione.
Può essere utile per:
- confrontare atenei con caratteristiche simili;
- valutare la coerenza tra reputazione e risultati scientifici;
- individuare università in crescita in settori specifici;
- capire dove si concentrano le collaborazioni internazionali più attive.
Per un’analisi completa conviene sempre incrociare i dati THE con quelli di altri ranking, rapporti ministeriali o indicatori nazionali (come Censis e Anvur). Solo così si ottiene una visione reale della qualità universitaria, al di là delle classifiche.
In sintesi, leggere bene una classifica significa andare oltre il numero: capire i criteri, valutare i contesti e leggere i trend. Solo così si può usare il Times Higher Education Ranking per ciò che è davvero: un osservatorio mondiale della conoscenza, non una semplice graduatoria di vincitori e vinti.
Prospettive e sintesi finale: verso la classifica 2027
La fotografia offerta dall’edizione 2026 della Times Higher Education World University Rankings mostra un sistema globale che cambia lentamente, ma in modo costante. L’élite anglosassone continua a dominare le prime posizioni, mentre Asia e Australia consolidano i propri progressi. L’Europa continentale tiene, ma deve fare i conti con modelli di governance più rigidi e investimenti spesso inferiori.
Per l’Italia, il bilancio è duplice. Da un lato, cresce la presenza complessiva nella classifica: più università entrano nelle fasce medio-alte, segno che la qualità della ricerca e dell’insegnamento è diffusa e riconosciuta. Dall’altro, rimane il nodo dell’internazionalizzazione e del finanziamento strutturale: due fattori decisivi per competere con i grandi poli globali. I prossimi anni saranno cruciali per capire se gli atenei italiani sapranno trasformare i segnali positivi del 2026 in una crescita stabile.
Le strade possibili sono tre:
- investire nella ricerca internazionale, attraverso progetti europei e partnership pubblico-private;
- rendere più attrattivi i percorsi di dottorato e post-doc, per trattenere talenti e competenze;
- valorizzare l’impatto sociale e industriale della ricerca, migliorando la connessione tra università e territorio.
In un mondo in cui la conoscenza è ormai una risorsa strategica, la classifica THE resta una bussola: non dice tutto, ma indica le direzioni verso cui si muove la qualità accademica globale.
E se l’edizione 2026 conferma l’Italia tra i protagonisti emergenti, la vera sfida — per il 2027 — sarà trasformare la presenza in visibilità, e la visibilità in leadership.