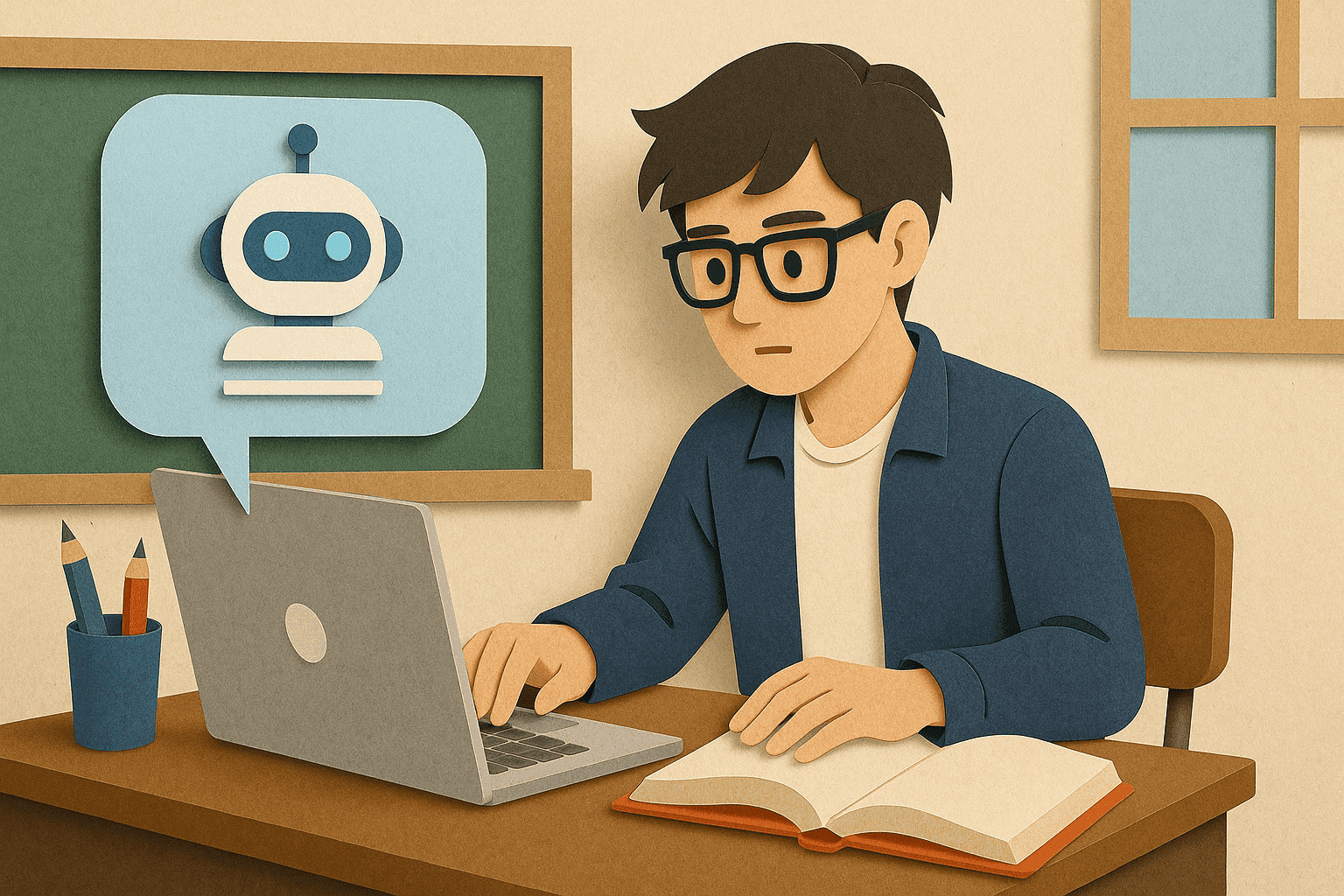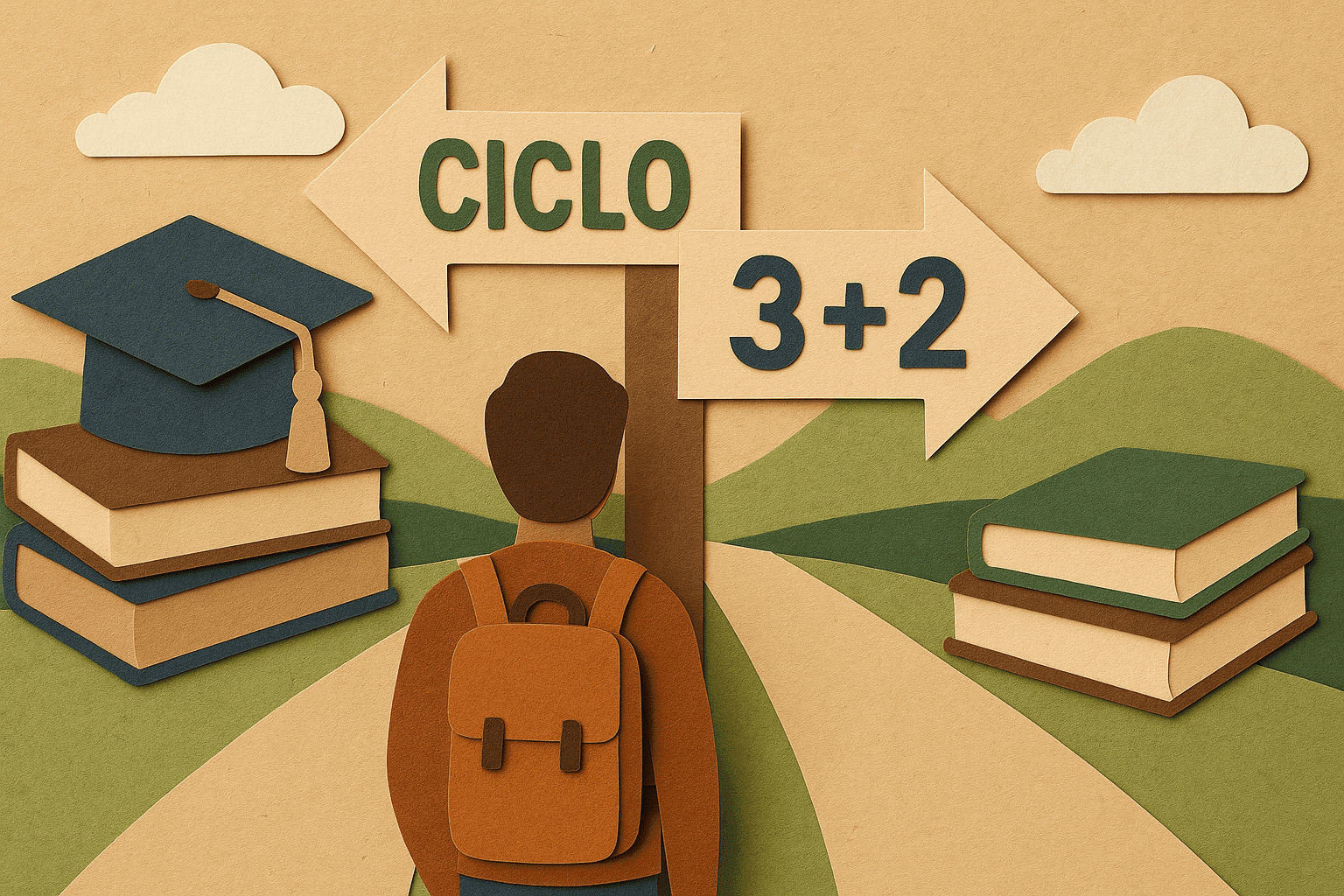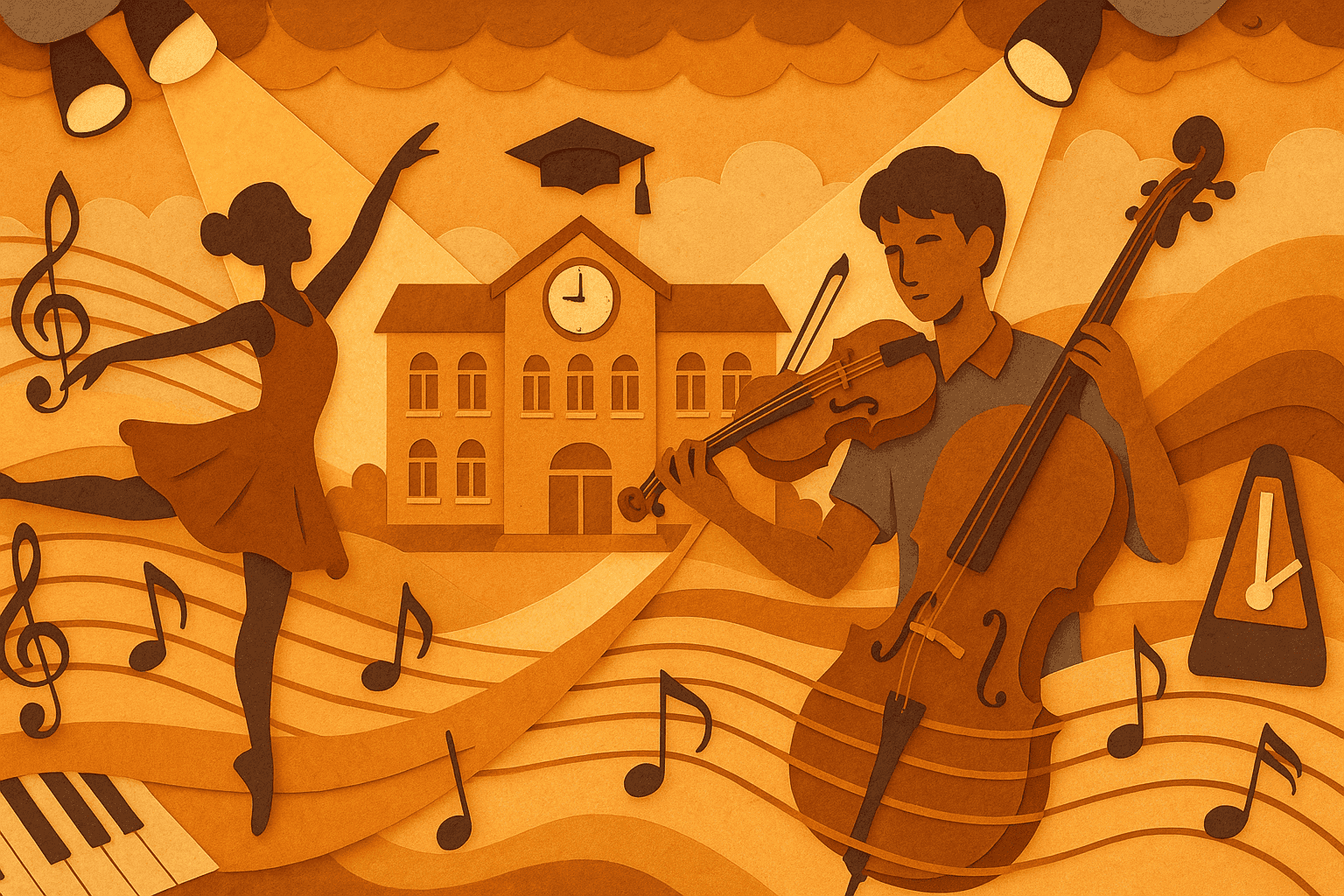Le gite scolastiche – ufficialmente chiamate viaggi d’istruzione – sono da decenni parte integrante dell’esperienza formativa italiana. Eppure, negli ultimi anni, organizzare e realizzare questi viaggi è diventato sempre più difficile. Normative incerte, costi in aumento e soprattutto la carenza di insegnanti disposti ad accompagnare gli studenti stanno mettendo a rischio quella che un tempo era considerata una tappa quasi obbligata di ogni anno scolastico. Di seguito esploriamo l’importanza educativa delle gite, le cause della loro crisi recente e le possibili soluzioni per salvare questa preziosa tradizione.
L’importanza educativa dei viaggi d’istruzione
Una gita scolastica non è “solo una vacanza” ma un’esperienza didattica a tutti gli effetti. Uscire dall’aula e viaggiare con i compagni offre agli studenti opportunità uniche di apprendimento sul campo: si visitano luoghi di interesse storico, artistico o scientifico, si entra in contatto diretto con culture e territori diversi, si impara a collaborare e a vivere insieme per qualche giorno fuori dalla routine quotidiana. Molti educatori concordano che i viaggi d’istruzione rappresentano momenti formativi fondamentali: consolidano il gruppo classe, stimolano curiosità e crescita personale, sviluppano l’autonomia e le competenze sociali degli alunni.
Non a caso, nel vissuto degli studenti le gite rimangono tra i ricordi più belli della scuola. “Indiscutibile che i viaggi di istruzione siano uno dei momenti più felici del percorso scolastico”, ha osservato a tal proposito Cristina Costarelli, dirigente scolastica e presidente dell’Associazione Nazionale Presidi (ANP) per il Lazio. Da sempre queste esperienze vengono considerate parte integrante della missione educativa: la scuola esce dai libri e diventa vita vissuta, offrendo una formazione attiva fuori dalle mura scolastiche. Proprio per questo, diversi esperti chiedono di riconoscere ufficialmente il valore pedagogico delle gite anche a livello amministrativo, e non trattarle alla stregua di semplici servizi commerciali turistici.
La crisi delle gite scolastiche negli ultimi anni
Negli ultimi 4-5 anni le gite scolastiche hanno attraversato una crisi senza precedenti. Già il biennio della pandemia Covid-19 (2020-2021) aveva imposto uno stop forzato a qualsiasi viaggio. Ma anche con la ripresa delle attività in presenza, i numeri sono rimasti allarmanti: moltissime classi hanno rinunciato ai viaggi di più giorni fuori sede. Secondo un osservatorio annuale di Skuola.net, nel 2023 e 2024 circa la metà degli studenti delle scuole medie e superiori non ha partecipato ad alcun viaggio d’istruzione con pernottamento. In concreto, uno studente su due è rimasto a casa mentre i suoi compagni partivano – o, più spesso, l’intera scuola ha evitato di organizzare viaggi di più giorni. Spesso si è ripiegato al massimo su uscite giornaliere locali, oppure si è rinunciato del tutto.
Le cause di questa crisi sono molteplici. L’indagine citata evidenzia due motivazioni principali: la mancanza di docenti disponibili come accompagnatori e i costi troppo elevati per le famiglie. In quasi 4 casi su 10, infatti, le gite saltano perché non si trovano abbastanza professori disposti a prendersi la responsabilità di portare in viaggio decine di ragazzi. Parallelamente, circa 1 caso su 8 salta principalmente per ragioni economiche, con pacchetti viaggio divenuti troppo cari. Da non sottovalutare anche altri fattori: ad esempio un 17% degli studenti che non vanno in gita riferisce di essere stato escluso per motivi disciplinari (come punizione per comportamenti scorretti a scuola).
L’effetto di questi problemi è visibile anche nelle caratteristiche delle poche gite che si svolgono: oggi, quando si parte, si cerca di ridurre al minimo durata e distanza per contenere i costi. Quasi la metà delle classi in viaggio non supera i tre giorni fuori casa, scegliendo spesso mete italiane raggiungibili in pullman. Itinerari all’estero o soggiorni più lunghi sono diventati rari. Inoltre, capita di frequente che non tutti gli studenti partecipino, perché alcuni rinunciano per motivi economici: si vedono classi partire con meno della metà degli alunni, cosa impensabile fino a qualche anno fa. Insomma, l’esperienza della gita scolastica si sta trasformando da momento condiviso da un’intera comunità scolastica a privilegio per pochi.
Professori in fuga: perché mancano gli accompagnatori
Il nodo più critico emerso è la crescente indisponibilità degli insegnanti ad accompagnare gli studenti in gita. In Italia non esiste un obbligo di legge che imponga ai docenti di fare da accompagnatori: la partecipazione è volontaria, e senza sufficiente personale disponibile il viaggio semplicemente non può avere luogo. Oggi molti dirigenti scolastici faticano a comporre il gruppo minimo di professori richiesto per partire (di solito almeno 1 docente ogni 15 alunni, secondo i regolamenti interni). Di conseguenza, numerose gite vengono cancellate in fase organizzativa per mancanza di accompagnatori.
Perché sempre meno docenti si offrono volontari? Le ragioni vanno ricercate nelle condizioni gravose in cui il personale deve operare durante i viaggi, a fronte di scarsi riconoscimenti. Anzitutto c’è un forte timore legato alle responsabilità. La normativa italiana attribuisce ai docenti accompagnatori una responsabilità di vigilanza continua e “qualificata” sugli studenti per l’intera durata della gita, 24 ore su 24. Ciò significa che l’insegnante è legalmente responsabile per qualsiasi incidente capiti agli alunni sotto la sua supervisione, potendo incorrere in sanzioni civili e persino penali in caso di eventi gravi. Purtroppo episodi tragici non sono mancati: negli ultimi anni si sono registrati incidenti durante uscite didattiche, inclusi casi mortali, che hanno avuto grande eco sui media e hanno gettato nello sconforto la comunità scolastica. Ogni volta, inevitabilmente, si riapre il dibattito sulle enormi responsabilità in capo ai docenti accompagnatori.
Gli insegnanti dunque sentono questo peso sulle spalle e spesso non si sentono tutelati a sufficienza. Molti fanno notare di non aver ricevuto formazione specifica su gestione delle emergenze, pronto soccorso o sicurezza durante le uscite. E sanno che, in caso di problemi, la tendenza è quella di attribuire la colpa a loro per “mancata sorveglianza”. “Non andrei a scherzare sulla responsabilità e l’impegno che assumono i docenti quando si rendono disponibili come accompagnatori” – ha scritto ancora la preside Costarelli – “Quale altro lavoratore assumerebbe l’onere di passare la notte a controllare che i ragazzi non si calino dalle finestre, gratuitamente?”. La battuta sarcastica rende bene l’idea: portare una classe in gita significa, per il docente, lavorare giorno e notte per garantire l’incolumità di decine di adolescenti spesso vivaci e imprevedibili. Un impegno stressante, che richiede lucidità e attenzione costante, senza pause.
Oltre al rischio di incidenti, infatti, c’è la gestione quotidiana della disciplina: fuori dall’ambiente scolastico i ragazzi tendono a sentirsi “in vacanza” e a lasciarsi andare, e il tasso di turbolenza è aumentato negli ultimi tempi (come segnalano diversi insegnanti post-pandemia). Controllare gruppi numerosi in hotel, sui mezzi di trasporto, per le strade di città sconosciute, prevenire bravate notturne o comportamenti pericolosi – tutto questo ricade sui docenti accompagnatori, spesso in sottorganico rispetto alle necessità reali. Non aiuta il fatto che il corpo docente italiano abbia un’età media elevata: molti professori cinquantenni o sessantenni trovano fisicamente gravoso seguire ragazzini instancabili in escursioni e visite per più giorni di fila, dormendo poco e male. In queste condizioni, molti preferiscono dire di no sin dall’inizio.
Nessun incentivo economico: accompagnare “gratis et amore dei”
Alle difficoltà e responsabilità pesanti non corrisponde alcun vantaggio materiale per l’insegnante, anzi. Uno dei motivi principali di scontento tra i docenti è infatti la totale mancanza di incentivi economici per chi accompagna le gite. Fino a quindici anni fa esisteva una diaria, ossia un’indennità giornaliera di trasferta, riconosciuta agli insegnanti in viaggio d’istruzione. Tuttavia, a partire dal 2006 (per i viaggi in Italia) e dal 2010 (per quelli all’estero), queste indennità sono state abolite per legge nell’ottica di contenere la spesa pubblica. Da allora i docenti non ricevono più alcun compenso aggiuntivo per le ore extra prestate durante le gite.
In pratica, oggi ad un accompagnatore viene rimborsato al massimo il vitto e l’alloggio, quando non siano offerti gratuitamente dall’agenzia di viaggi, ma non viene pagato il lavoro extra. Le giornate (e nottate) spese in viaggio non danno diritto né a straordinari né a particolari recuperi di riposo – se non in forma molto limitata. Spesso l’unico riconoscimento è un piccolo bonus forfettario a fine anno prelevato dal fondo di istituto della scuola, una cifra simbolica di poche decine di euro quando disponibile. Molti insegnanti infatti subiscono anche la beffa di sentirsi dire, magari da qualche genitore, che “accompagnando la classe si fanno una gita gratuita”. In realtà, come abbiamo visto, per il professore la gita è tutt’altro che un viaggio di piacere.
Questa situazione di volontariato forzato – impegno gravoso senza compenso – ha comprensibilmente raffreddato l’entusiasmo di tanti docenti. Non stupisce che, in un sondaggio nazionale, circa il 22% degli insegnanti indichi nella retribuzione inadeguata la ragione principale per cui evita di dare la disponibilità per le uscite. Molti parlano apertamente di sfruttamento: accompagni “per amore” verso gli studenti, per offrire loro un’esperienza di crescita, ma a livello professionale il tuo lavoro aggiuntivo non viene riconosciuto né economicamente né contrattualmente.
Da tempo i sindacati della scuola chiedono di reintrodurre un’indennità per i docenti in viaggio d’istruzione. Sul tema è intervenuto anche l’attuale Ministro dell’Istruzione: nel 2025 Giuseppe Valditara ha dichiarato pubblicamente che “il docente che accompagna gli studenti deve avere un riconoscimento economico”, annunciando l’intenzione di ripristinare la vecchia diaria. Si tratta di un segnale importante – finalmente anche a livello politico si ammette che il lavoro extra va pagato – ma al momento (anno scolastico 2024/25) questa resta un’intenzione non ancora tradotta in realtà. I docenti dunque continuano a doversi fare carico delle gite “gratis et amore Dei”, sperando che le promesse di un compenso aggiuntivo vengano presto mantenute.
Studenti e famiglie tra entusiasmo e preoccupazioni
La crisi delle gite scolastiche colpisce direttamente studenti e famiglie, che da una parte riconoscono il valore formativo di queste esperienze, dall’altra si scontrano con gli ostacoli pratici. Per molti ragazzi la gita rappresenta un momento attesissimo di crescita e divertimento: non poter partire, oppure accontentarsi di un’uscita minore, può significare perdere un’occasione unica di socializzazione e di apprendimento fuori dagli schemi. Soprattutto dopo gli anni difficili della pandemia, c’era grande voglia di tornare a viaggiare in compagnia della scuola. Non a caso, le famiglie spesso sollecitano gli istituti a organizzare i viaggi di istruzione.
D’altro canto, però, anche i genitori vivono alcune preoccupazioni legate alle gite. La prima è sicuramente quella economica: i costi dei viaggi scolastici sono aumentati, risentendo dell’inflazione generale e del caro-trasporti. Un pacchetto di 3-4 giorni in Italia può costare diverse centinaia di euro a studente; per l’estero si può superare facilmente la soglia dei mille euro, specie per destinazioni lontane. Non tutte le famiglie riescono a permetterselo, e questo crea disuguaglianze. Nel 2024 alcune scuole hanno utilizzato fondi ministeriali straordinari per aiutare gli studenti meno abbienti a pagare la quota della gita, ma si tratta di misure sporadiche e spesso insufficienti. Così molti genitori si trovano costretti a negare il consenso alla partecipazione dei figli per ragioni di budget, a malincuore. Oppure spingono per soluzioni “low cost”, come viaggi più brevi, mete più vicine o periodi di bassa stagione, pur di salvare l’esperienza.
Un’altra fonte di apprensione per le famiglie riguarda la sicurezza. Gli incidenti (per quanto rari) e il racconto di docenti lasciati soli ad affrontare emergenze hanno fatto crescere la consapevolezza dei rischi. Alcuni genitori oggi chiedono garanzie sulle misure di sicurezza adottate durante le uscite: vogliono sapere che ci sarà un numero adeguato di accompagnatori, che i ragazzi saranno sorvegliati a dovere, che in caso di problemi la scuola ha protocolli chiari e assicurazioni pronte a coprire eventuali danni. In sostanza, le famiglie desiderano trasparenza e organizzazione: apprezzano i viaggi d’istruzione, ma esigono che siano gestiti con professionalità e che la responsabilità sia condivisa (non scaricata solo sull’insegnante di turno).
Dal punto di vista educativo, comunque, genitori e studenti restano in gran maggioranza favorevoli alle gite. Gli studenti, in particolare, vivono la mancanza di queste occasioni come una perdita: si sentono penalizzati rispetto alle generazioni precedenti che ricordano con entusiasmo i viaggi scolastici. L’auspicio comune è che si trovino soluzioni perché questa attività fondamentale possa continuare in modo diffuso e accessibile a tutti.
Burocrazia e nuove regole: un ulteriore ostacolo
Come se non bastassero i fattori sopra descritti, recentemente si è aggiunto anche un nodo burocratico-normativo a complicare l’organizzazione delle gite. Nel 2023 è entrato in vigore un nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) che ha cambiato le regole per gli acquisti delle pubbliche amministrazioni, incluse le scuole. In base a questa normativa, gli istituti scolastici per poter indire gare d’appalto di importo sopra una certa soglia devono essere “qualificati” come stazioni appaltanti oppure appoggiarsi a centrali di committenza esterne. Questo ha creato notevole confusione: improvvisamente i dirigenti e i DSGA (direttori amministrativi) delle scuole si sono trovati di fronte a procedure più complesse per affidare i servizi delle gite (trasporto, alloggio, pacchetti agenzia), con il rischio concreto di non poter fare in tempo a organizzare i viaggi.
Nel 2024 il Ministero dell’Istruzione ha provato a correre ai ripari emanando un decreto (DPCM n.185/2024) che coinvolge gli Uffici Scolastici Regionali (USR): questi uffici territoriali dovrebbero fungere da supporto qualificato per le scuole, aiutandole a gestire le gare per i viaggi d’istruzione di importo elevato. Tuttavia, l’attuazione pratica di questo sistema è risultata lenta e macchinosa. A inizio anno scolastico 2024/25 molte scuole non sapevano ancora a chi rivolgersi e quali USR fossero effettivamente operativi come “stazioni appaltanti” dedicate. In più, gli USR lamentavano di non avere il personale aggiuntivo promesso per svolgere questo compito (ben 161 nuovi funzionari previsti, non immediatamente disponibili). Organizzazioni di categoria come l’ANQUAP (Associazione nazionale dei quadri amministrativi della scuola) hanno lanciato l’allarme: “Troppa confusione, viaggi a rischio quest’anno” – ha scritto il presidente Giorgio Germani, chiedendo al Ministero di fornire urgentemente chiarimenti e risorse.
Fortunatamente, per evitare il blocco totale, si è intervenuti con alcune soluzioni ponte. L’Autorità Anticorruzione (ANAC) ha chiarito che le scuole rientrano tra le amministrazioni “sub-centrali”, il che consente loro soglie di spesa più alte (fino a €221.000) prima di dover ricorrere a procedure complesse – un’interpretazione più favorevole rispetto al passato. Inoltre, lo stesso Ministero sta lavorando a un sistema centralizzato: da metà 2025 è previsto un accordo con Consip (la centrale acquisti nazionale) per bandire gare uniche per i servizi di viaggi d’istruzione, così da offrire alle scuole pacchetti “chiavi in mano” e evitare che ogni istituto debba fare da sé. Dal gennaio 2026, poi, dovrebbero entrare a regime gli USR come supporto stabile, una volta formati e potenziati. Insomma, si cerca di sburocratizzare e rendere più efficiente l’organizzazione tecnica delle gite, ma nel frattempo la fase di transizione ha aggiunto stress alle scuole e rischi di ulteriori rinunce ai viaggi.
Va sottolineato che queste questioni normative, pur importanti, sono solo una parte del problema. Come abbiamo visto, anche garantendo procedure amministrative snelle, resterebbero da risolvere le questioni umane e professionali: servono professori disponibili, motivati e messi in condizione di operare con serenità. La burocrazia può essere semplificata con decreti e piattaforme digitali, ma senza un corpo docente disposto ad accompagnare, nessuna gita potrà comunque partire.
Possibili soluzioni e appelli dal mondo della scuola
Di fronte a questa situazione complessa, il mondo della scuola negli ultimi anni si è mobilitato proponendo soluzioni e richieste precise per salvare i viaggi d’istruzione. Dirigenti, insegnanti, studenti e genitori, nonché associazioni professionali e sindacati, concordano su alcuni punti chiave:
-
Ripristinare un compenso dignitoso per i docenti accompagnatori: è la richiesta forse più condivisa. Occorre prevedere per legge un’indennità giornaliera o un pagamento forfettario per le ore extra svolte in gita, valido in tutte le scuole d’Italia. Ciò restituirebbe dignità al lavoro dei docenti e li incentiverebbe a partecipare senza sentirsi sfruttati. Su questo punto c’è apertura ministeriale, ma bisogna accelerare i tempi perché diventi realtà operativa.
-
Formazione e tutela per gli insegnanti in viaggio: vengono proposti corsi obbligatori per docenti accompagnatori su gestione dei rischi, primo soccorso, sicurezza e aspetti legali. Sapere come affrontare un’emergenza o conoscere i propri doveri e diritti in caso di incidente può rendere gli insegnanti più sereni nell’assumere il ruolo. Allo stesso tempo si chiede di rafforzare le coperture assicurative per studenti e docenti durante le uscite, così che eventuali incidenti non ricadano sul singolo accompagnatore ma siano gestiti da sistemi di tutela collettiva.
-
Standard nazionali per sicurezza e organizzazione: l’esperienza attuale, frammentata per ogni scuola, ha mostrato limiti. Si invoca la definizione di linee guida unitarie: ad esempio fissare un rapporto minimo accompagnatori/studenti (c’è chi suggerisce 1 adulto ogni 10 alunni nelle gite con pernottamento), protocolli uniformi su come gestire le emergenze, obbligo per ogni istituto di stipulare assicurazioni adeguate prima di partire, ecc. Questo darebbe maggiori garanzie sia al personale sia alle famiglie, riducendo le disparità tra scuole organizzate e scuole in difficoltà.
-
Coinvolgimento di figure esterne e supporto aggiuntivo: per alleviare il carico sui docenti, alcune proposte suggeriscono di poter includere accompagnatori esterni qualificati, ad esempio guide, educatori professionali o genitori formati, almeno per compiti di vigilanza non didattica. Inoltre si chiede che le scuole abbiano accesso a risorse per coprire supplenze interne: spesso infatti un docente che va in gita lascia scoperta la sua classe per quei giorni, creando problemi nell’orario. Garantire organici flessibili o personale supplente in questi casi aiuterebbe a superare le resistenze di chi teme di “lasciare indietro” il programma nelle proprie materie.
Parallelamente, c’è un appello a considerare i viaggi d’istruzione alla stregua di attività didattiche a tutti gli effetti e non come un di più opzionale. Questo significa inserirli meglio nella programmazione scolastica e magari prevedere nei finanziamenti statali dei capitoli dedicati. Alcuni politici e dirigenti propongono l’adozione di un “codice nazionale delle uscite didattiche”, una sorta di riforma complessiva che metta ordine nella giungla di circolari e regole ufficiose, attribuendo chiaramente responsabilità e compiti tra scuola, famiglie, enti esterni e docenti.
Infine, non va dimenticata la richiesta di sostenere economicamente le famiglie per rendere le gite accessibili a tutti gli studenti. Che senso ha organizzare un viaggio educativo se poi buona parte della classe resta a terra perché non può pagarlo? Si parla quindi di incentivi, borse di studio ad hoc, tariffe calmierate concordate con i fornitori, e in generale di politiche per il diritto allo studio “in uscita”.
Preservare un’esperienza formativa irrinunciabile
Le gite scolastiche rappresentano un patrimonio educativo e culturale che l’Italia non può permettersi di perdere. L’attuale crisi – fatta di metà studenti fermi a casa, professori esausti o impauriti che rifiutano di partire, e scuole imbrigliate tra costi e burocrazia – è il sintomo di un sistema che necessita di interventi urgenti. Salvare i viaggi d’istruzione significa garantire agli studenti opportunità di crescita integrale e agli insegnanti condizioni di lavoro rispettose della loro professionalità.
Da un lato, occorre restituire attrattiva e sostenibilità a questa attività per i docenti: riconoscerne il valore con adeguati compensi economici, formazione mirata e tutela sul piano delle responsabilità. Dall’altro, bisogna assicurare equità per gli studenti, affinché la partecipazione non sia limitata solo a chi ha più possibilità economiche o alla buona volontà dei singoli. Il Ministero dell’Istruzione e tutti gli attori coinvolti (scuole, sindacati, associazioni di genitori) sono chiamati a fare la propria parte: semplificando le regole organizzative, destinando risorse, e promuovendo una cultura scolastica che veda nelle gite un investimento educativo e non un lusso.
In conclusione, le gite scolastiche sono molto più che un momento di svago: sono esperienze formative insostituibili, dove si imparano lezioni di vita che nessun libro di testo potrà mai trasmettere. Preservarle vuol dire credere in una scuola aperta al mondo e capace di offrire ai ragazzi non solo nozioni, ma anche memorie ed emozioni destinate a durare tutta la vita. La speranza è che, grazie a interventi mirati e alla sensibilizzazione generale, si possa invertire la rotta: tornando a vedere pullman carichi di studenti in partenza, insegnanti più sereni nel guidarli e famiglie fiduciose ad aspettarli al ritorno. Sarebbe un segnale di rinascita importante per tutta la comunità scolastica.