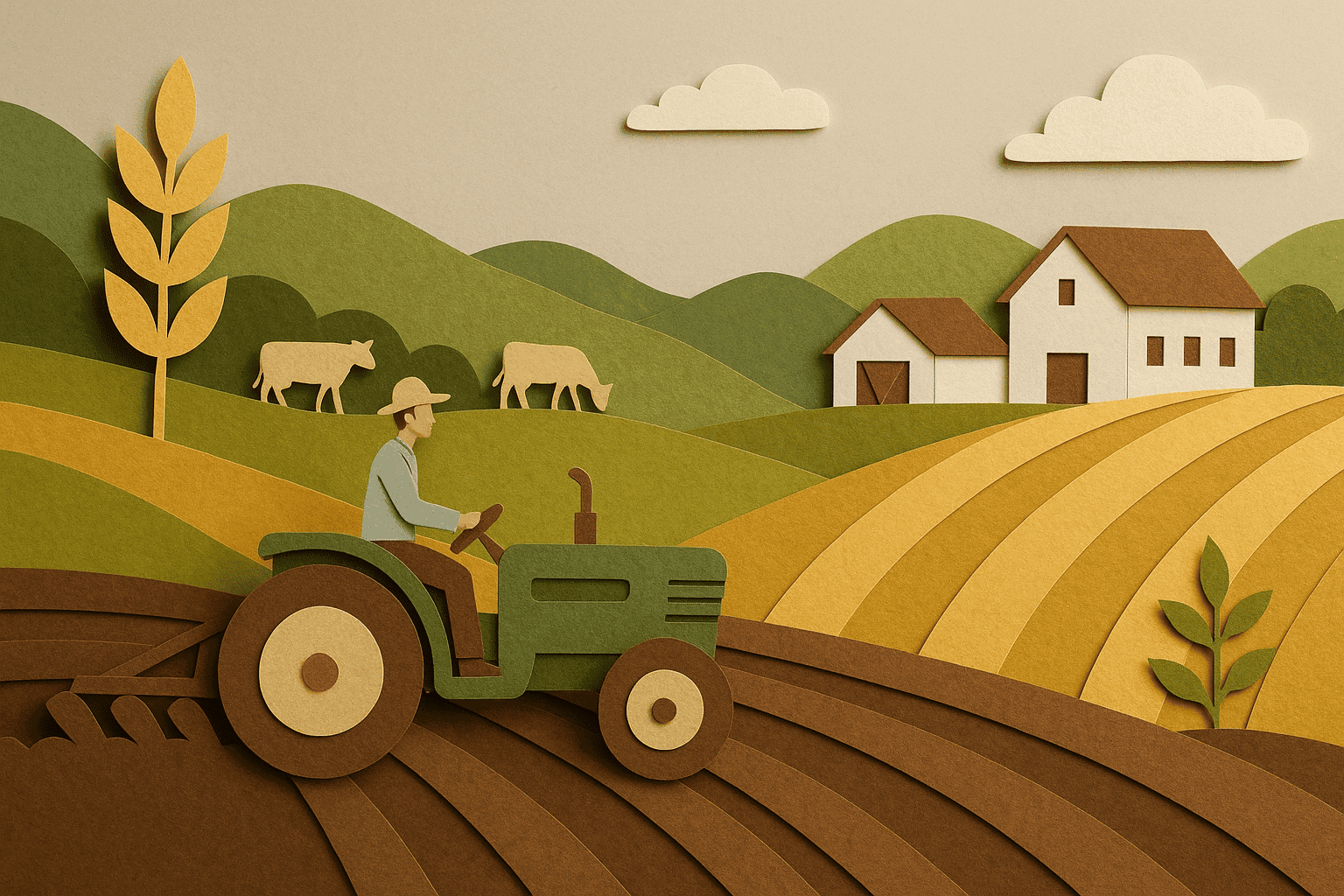Capire quale strada formativa intraprendere è complicato, che tu abbia 13 o 17 anni. La scelta della scuola superiore, dell’università o di un percorso professionale può diventare un momento carico di dubbi e preoccupazioni. Anche gli adulti, che dovrebbero dare supporto nella fase della scelta, si trovano spesso disorientati.
Per rispondere alla necessità di studenti, genitori e insegnanti di districarsi nel mondo dell’orientamento, il Ministero dell’Istruzione ha introdotto una riforma dell’orientamento scolastico, con l’obiettivo di renderlo più strutturato, continuo e vicino ai bisogni reali degli studenti. Questa riforma parte da una semplice ma potente idea: ogni ragazzo e ragazza ha il diritto di essere accompagnato nel costruire, passo dopo passo, il proprio progetto di vita.
Un orientamento che inizia presto e dura nel tempo
La novità più importante è che l’orientamento non è più pensato come un momento isolato, magari solo alla fine del percorso scolastico, ma come un processo che inizia già durante la scuola media e prosegue fino al diploma. Accompagna lo studente anno dopo anno, aiutandolo a riflettere su chi è, cosa gli piace fare, quali sono i suoi punti di forza, quali percorsi lo ispirano e cosa può voler dire, per lui o lei, costruire un futuro soddisfacente.
Questo nuovo modello di orientamento prevede anche che le attività siano integrate nel percorso scolastico ordinario. In particolare, già nei primi due anni delle scuole superiori, gli studenti avranno a disposizione ore dedicate all’orientamento formativo, mentre negli anni successivi l’attenzione si sposterà maggiormente sul rapporto con il mondo del lavoro e della formazione post-diploma.
Due nuove figure: il tutor e l’orientatore
Per rendere il nuovo modello di orientamento più efficace, il Ministero ha previsto l’introduzione di due figure specifiche all’interno delle scuole: il docente tutor e il docente orientatore. Non sono professionisti esterni, ma insegnanti interni all’istituto che scelgono di svolgere questo ruolo aggiuntivo dopo una formazione dedicata.
Il tutor è un insegnante della scuola, preferibilmente con una buona conoscenza dei propri studenti e con competenze relazionali. Può appartenere a qualsiasi disciplina – non è necessario che insegni materie specifiche – ma deve essere disponibile a seguire gruppi di studenti in modo continuativo e personalizzato.
L’assegnazione non avviene su scelta dello studente: è la scuola, di solito tramite il dirigente scolastico o il consiglio di classe, a formare i gruppi e a stabilire chi seguirà chi, in base a criteri organizzativi e didattici. Tuttavia, una volta creato il legame, il tutor diventa una figura stabile di riferimento per tutto il ciclo scolastico.
Il tutor accompagna gli studenti in un percorso di riflessione su sé stessi, sulle proprie competenze e sugli obiettivi futuri. Non fornisce semplicemente informazioni sulle scuole o sulle professioni, ma li aiuta a leggere con consapevolezza le proprie esperienze scolastiche, le passioni, i risultati e le difficoltà. Il suo lavoro si svolge attraverso:
- colloqui individuali o in piccoli gruppi,
- momenti di confronto su obiettivi personali e scolastici,
- supporto nella compilazione del “capolavoro orientativo”,
- dialogo con le famiglie, quando necessario.
In molti casi, il tutor è anche la figura che aiuta lo studente a interpretare i risultati dei test attitudinali, a ragionare sulle scelte post-diploma e a collegare il percorso scolastico alle opportunità future.
Diverso è il ruolo dell’orientatore, che lavora a un livello più strategico. Anche lui è un docente della scuola, ma con il compito di progettare e coordinare tutte le attività orientative dell’istituto. Nel concreto, si occupa di:
- organizzare eventi informativi e incontri con esperti esterni,
- attivare collaborazioni con università, enti di formazione, aziende del territorio,
- scegliere e promuovere strumenti digitali di orientamento,
- supportare gli altri docenti (compresi i tutor) nella costruzione di percorsi efficaci.
Per esempio, può essere lui a contattare un’università locale per far partecipare gli studenti a un open day, o a organizzare una visita aziendale per far scoprire come funziona una determinata professione. Oppure può predisporre una settimana di attività dedicate all’orientamento, in cui ogni classe lavora su un progetto collegato al futuro formativo o lavorativo.
Queste due figure – tutor e orientatore – non lavorano in modo isolato, ma in sinergia. Il tutor accompagna il singolo studente, l’orientatore lavora sulla visione d’insieme. Entrambi contribuiscono a trasformare l’orientamento da momento episodico a processo strutturato e continuo.
Il capolavoro orientativo: una mappa personale per decidere meglio
Il capolavoro orientativo è una delle innovazioni più interessanti introdotte dalla riforma. È un progetto personale che ogni studente costruisce nel tempo, raccogliendo materiali, riflessioni ed esperienze che raccontano il proprio percorso scolastico e formativo. Non è un compito da svolgere una tantum, ma un lavoro in divenire, che accompagna lo studente per più anni e lo aiuta a mettere a fuoco chi è, cosa sa fare e dove vuole andare.
Il contenuto del capolavoro può variare molto da studente a studente. C’è chi inizia con una semplice pagina Word in cui annota ciò che gli è piaciuto in una visita aziendale, chi crea una presentazione in PowerPoint con le materie preferite e i propri punti di forza, chi realizza un piccolo sito web per raccogliere foto, appunti, test attitudinali e persino brevi video in cui racconta cosa ha imparato da un laboratorio teatrale o da un progetto di robotica. In alcuni istituti vengono proposte piattaforme digitali comuni, come Google Sites o Padlet, mentre altrove si lavora su formato cartaceo, come un vero e proprio diario.
Un esempio concreto: uno studente che ama la cucina potrebbe inserire nel proprio capolavoro il racconto di uno stage in un ristorante, le foto di un laboratorio di alimentazione, i risultati di un test attitudinale che evidenzia un’alta manualità e riflessioni personali su come si è sentito durante quell’esperienza. Un’altra ragazza, appassionata di scienze, potrebbe includere nel proprio portfolio il resoconto di un esperimento fatto in classe, la partecipazione a un evento scientifico e una lettera motivazionale scritta per una scuola estiva di orientamento.
Il capolavoro non è valutato né deve rispettare un formato rigido. L’obiettivo non è “fare bella figura”, ma creare uno spazio in cui raccogliere esperienze autentiche e dare senso al proprio percorso. Viene aggiornato gradualmente, spesso con il supporto del tutor, durante ore dedicate all’orientamento o in momenti condivisi con la classe. In alcune scuole si prevedono scadenze periodiche per inserirvi nuovi contenuti, in altre si lascia maggiore libertà, ma con l’idea di arrivare a fine ciclo scolastico con un documento completo e rappresentativo.
Più che un esercizio formale, il capolavoro orientativo è una mappa personale che aiuta a fare ordine, a collegare tra loro episodi scolastici e extrascolastici, e a riflettere su ciò che davvero conta per costruire il proprio futuro. Quando arriva il momento di fare una scelta – che sia il passaggio a un altro indirizzo scolastico o la decisione su cosa fare dopo il diploma – lo studente può ripartire da lì: da ciò che ha raccolto, capito e vissuto nel tempo.
Orientamento alle medie: esplorare prima di scegliere
L’estensione dell’orientamento già alla scuola secondaria di primo grado è una delle novità più significative della riforma. Non si tratta di anticipare decisioni o di forzare scelte premature, ma di offrire ai ragazzi e alle ragazze spazi protetti per iniziare a conoscersi, a confrontarsi con il mondo e ad allenare la propria capacità di immaginare il futuro. In questa fascia d’età – spesso segnata da insicurezze, cambiamenti e prime scoperte – l’orientamento diventa un percorso di esplorazione, più che di selezione.
A scuola, queste attività si traducono in esperienze molto diverse tra loro, tutte con un obiettivo comune: rafforzare l’identità, la fiducia in sé e la curiosità. In alcune classi si lavora su laboratori esperienziali, dove i ragazzi possono mettersi in gioco in contesti nuovi: una giornata in un laboratorio di falegnameria, la partecipazione a un progetto teatrale, un’attività di coding base o la simulazione di una redazione giornalistica. Sono momenti che permettono ai ragazzi di scoprire capacità che magari non emergono nel contesto scolastico tradizionale.
Molti istituti propongono anche incontri con professionisti che raccontano la propria esperienza lavorativa in modo semplice e diretto: una veterinaria che parla del suo percorso, un cuoco che spiega com’è nata la sua passione, un tecnico informatico che descrive come si è avvicinato al mondo della tecnologia. Spesso, proprio grazie a questi racconti, nascono nuove domande e si accendono piccole scintille di interesse.
In altri casi, l’orientamento si intreccia con le materie scolastiche. Ad esempio, un progetto interdisciplinare tra arte e storia può portare gli studenti a immaginare e progettare una mostra, oppure un’attività in geografia può diventare l’occasione per esplorare professioni legate all’ambiente, al turismo o alla cooperazione internazionale. Anche la visita a una scuola superiore, preparata in classe e seguita da un momento di confronto, può rappresentare un passo importante nel processo di orientamento.
Tutte queste attività non servono a “decidere cosa fare da grandi”, ma a conoscere meglio se stessi e a scoprire che esistono molti più percorsi di quanto si possa immaginare a 12 o 13 anni. È in questa fase che si inizia a costruire un primo vocabolario del futuro: parole come “competenze”, “passioni”, “scelte” e “possibilità” entrano nel quotidiano dei ragazzi, non in modo teorico, ma vissuto. L’orientamento alla scuola media, quindi, non è un punto di arrivo, ma l’inizio di un percorso di consapevolezza, fatto di piccoli passi, esperienze concrete e domande aperte. È un modo per dire ai ragazzi che il futuro non è qualcosa che arriva all’improvviso, ma qualcosa che si costruisce, giorno dopo giorno, anche attraverso le emozioni, i dubbi e le scoperte che si vivono a scuola.
Le piattaforme digitali: strumenti ufficiali per orientarsi meglio
Per sostenere il nuovo modello di orientamento, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha messo a disposizione degli studenti e delle famiglie alcune piattaforme digitali istituzionali, pensate per offrire informazioni chiare e affidabili durante tutto il percorso scolastico. Si tratta di strumenti gratuiti, accessibili online, che possono essere utilizzati anche insieme a un insegnante o a un genitore, per facilitare il confronto e la riflessione.
Una delle principali è Io Scelgo, Io Studio, il portale ufficiale dell’orientamento scolastico. Qui si trovano spiegazioni semplici e aggiornate sui diversi indirizzi delle scuole superiori, sui percorsi di istruzione e formazione professionale, e sulle possibilità post-diploma. È un punto di partenza utile per chi sta cercando di capire come funziona il sistema educativo italiano e quali opzioni esistono.
Un altro strumento fondamentale è Scuola in Chiaro, che permette di esplorare le scuole del territorio attraverso una mappa interattiva. Inserendo il proprio comune o una parola chiave, è possibile visualizzare il profilo di ogni istituto, con informazioni su indirizzi di studio, attività progettuali, laboratori, orari, lingue offerte, ma anche su alcuni dati relativi agli esiti scolastici. Può essere molto utile, ad esempio, per confrontare due scuole tra cui si è indecisi o per scoprire realtà poco conosciute ma adatte alle proprie esigenze.
Entrambe queste piattaforme sono progettate per essere intuitive e fruibili anche da chi ha poca dimestichezza con la tecnologia. Se utilizzate con il supporto di un adulto di riferimento, possono diventare un primo passo concreto per fare scelte più consapevoli, senza lasciarsi guidare solo dal “passaparola” o dall’abitudine. In un momento in cui le possibilità sono tante e spesso confuse, avere accesso a fonti istituzionali e affidabili fa davvero la differenza
Orientamento e disuguaglianze: garantire le stesse opportunità a tutti
L’introduzione di un orientamento più strutturato e continuo rappresenta un passo importante verso una scuola più attenta alle esigenze degli studenti. Tuttavia, per essere davvero efficace, questa riforma deve raggiungere tutti, non solo chi parte da situazioni favorevoli. In Italia, infatti, non tutte le scuole hanno le stesse risorse, e non tutti gli studenti hanno le stesse possibilità di essere accompagnati nelle scelte. In molte aree interne o periferiche, ad esempio, mancano connessioni internet stabili, dispositivi digitali aggiornati o spazi adeguati per svolgere attività orientative in modo continuativo. Alcuni istituti fanno fatica a garantire la presenza di tutor formati o a creare relazioni con il territorio, come università, aziende o enti di formazione. In altri casi, i ragazzi non possono contare su adulti di riferimento – in famiglia o nella comunità – che li aiutino a interpretare le opportunità e a fare scelte informate.
Questa disparità rischia di trasformarsi in una vera e propria disuguaglianza di accesso al futuro. Chi vive in contesti fragili, spesso, non sceglie in base ai propri interessi o potenzialità, ma si adatta a ciò che è disponibile o a ciò che già conosce. È il meccanismo dell’orientamento “per sottrazione”: invece di esplorare, si restringe il campo. Per evitare che questo accada, è fondamentale che la riforma venga accompagnata da interventi concreti, soprattutto nei territori dove le condizioni di partenza sono più difficili. Servono azioni mirate: formazione accessibile per tutti i docenti, materiali utilizzabili anche offline, piattaforme leggere e intuitive, ma anche supporto tecnico, reti territoriali forti e fondi destinati proprio all’orientamento nei contesti più svantaggiati.
Alcune scuole, nonostante le difficoltà, hanno già avviato progetti innovativi: tutoraggio a distanza, gemellaggi tra istituti, collaborazioni con enti del terzo settore o università. In questi casi, anche con risorse limitate, si riesce a garantire agli studenti un orientamento di qualità. Ma per generalizzare queste buone pratiche, serve una visione inclusiva e sistemica, che riconosca il diritto all’orientamento come un diritto di tutti, non come un privilegio per chi parte avvantaggiato. Sebbene le Linee guida non dedichino una sezione esplicita ai contesti fragili, richiamano con forza i principi di equità, inclusione e personalizzazione, sottolineando il diritto di ogni studente a essere accompagnato nel proprio percorso, a prescindere dalle condizioni di partenza. Proprio per questo, è fondamentale che l’orientamento non si limiti a “raggiungere chi può”, ma diventi davvero accessibile a tutti, ovunque.
Le famiglie: da spettatori a alleati del futuro
Uno degli aspetti più importanti della riforma è il riconoscimento del ruolo centrale delle famiglie nel percorso di orientamento. Fino a oggi, i genitori sono spesso stati coinvolti solo nelle fasi finali della scelta scolastica, magari con un colloquio di pochi minuti o con l’invio di un modulo da firmare. Ora invece viene chiesto loro di essere parte attiva e costante, non spettatori, ma alleati educativi. Accompagnare i figli non significa decidere al posto loro, né forzarli verso ciò che si considera “più sicuro” o “più prestigioso”. Significa, piuttosto, creare uno spazio di ascolto e dialogo, dove i ragazzi possano esprimere dubbi, paure, desideri. In molti casi, basta poco: una chiacchierata dopo cena, una passeggiata senza fretta, o anche semplicemente il tempo per esplorare insieme le informazioni su una scuola o su un percorso formativo.
Nella pratica, ci sono genitori che si informano sulle giornate aperte delle scuole superiori e ci vanno con i figli, altri che aiutano a compilare il capolavoro orientativo raccontando aneddoti dell’infanzia, o ancora chi propone di fare insieme un test attitudinale, solo per stimolare la curiosità. Non serve essere esperti di scuola: serve esserci, senza giudizio, con la disponibilità ad accogliere anche scelte diverse dalle proprie aspettative.
Non tutti i ragazzi hanno la stessa facilità nel comunicare con i genitori, così come non tutte le famiglie hanno le stesse risorse culturali o emotive per affrontare questo percorso. È per questo che le scuole, con il supporto dei tutor e degli orientatori, sono chiamate a coinvolgere attivamente le famiglie, attraverso incontri informativi, materiali chiari e momenti di confronto. Quando questo dialogo si attiva, anche le decisioni diventano più serene e condivise.
Con questa riforma l’orientamento non è più un evento una tantum, ma un percorso continuo e centrato sulla persona. Si basa sulla relazione, sull’ascolto, sull’esperienza. Non spinge a decidere in fretta, ma aiuta a decidere meglio.
Con l’introduzione di figure dedicate, strumenti personalizzati, attività curricolari e risorse accessibili, la scuola si trasforma in un luogo che accompagna davvero ogni studente nella costruzione del proprio futuro.