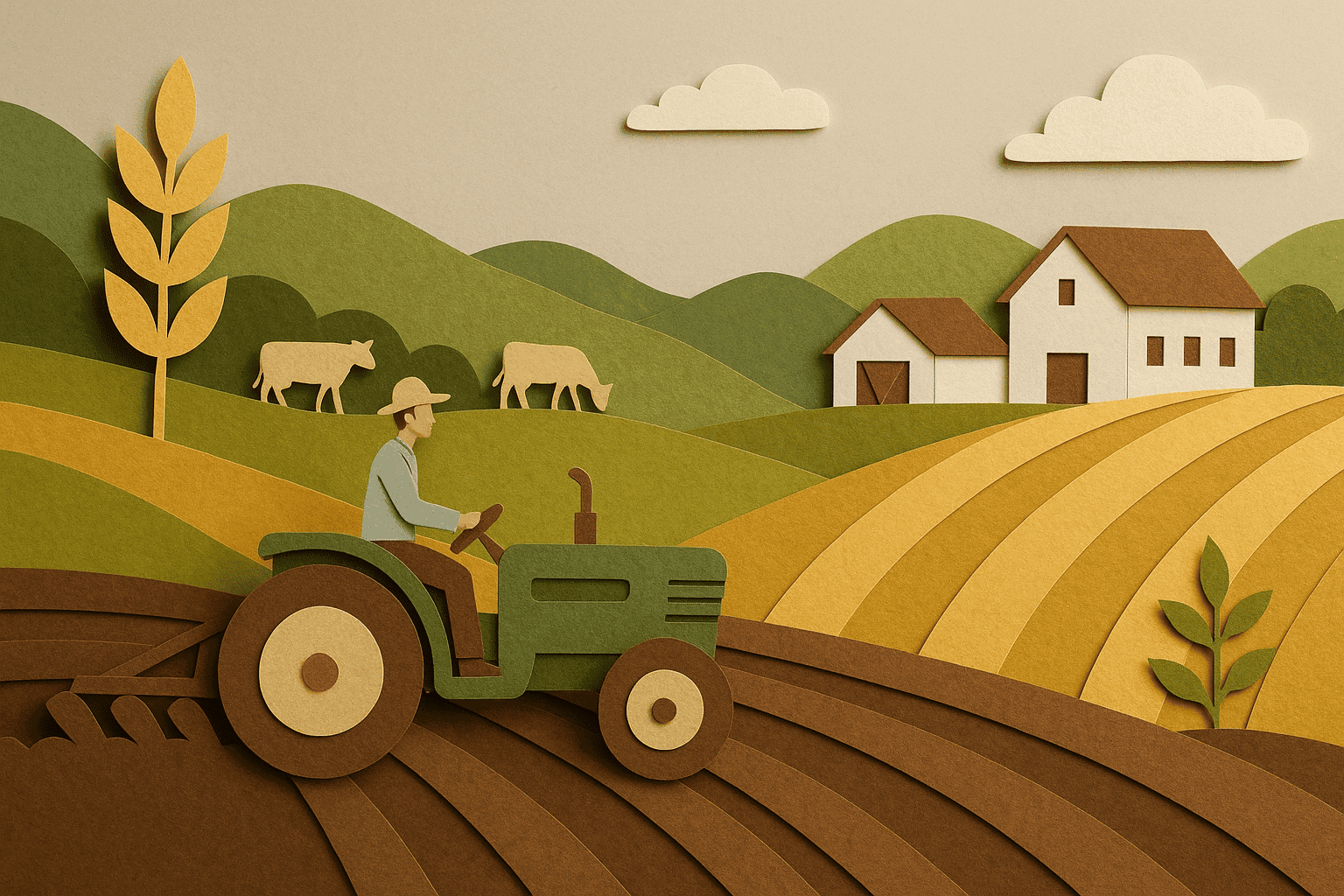Quante volte mi sono sentita chiedere: “Prof. a che università mi iscrivo? Non so che cosa fare” Questa domanda è tipica della nostra idea di orientamento. Infatti quando si parla di orientamento, si tende a immaginarlo come un momento specifico: quello in cui i ragazzi e le ragazze devono decidere quale scuola superiore o università scegliere. In realtà, questa è una visione riduttiva. L’orientamento è molto di più: è un processo continuo, che accompagna la persona lungo tutto l’arco della vita. Non riguarda solo il “cosa farò da grande”, ma piuttosto il “chi voglio essere nel mondo”.
Questa prospettiva più ampia ci permette di considerare l’orientamento non come un atto unico e definitivo, ma come una competenza vitale, che ci aiuta a muoverci in un mondo complesso, incerto, in continuo cambiamento. Scegliere, in fondo, non è mai un gesto isolato: è il risultato di un percorso fatto di riflessioni, errori, nuove possibilità, occasioni colte o mancate e bisognerebbe aver acquisito un metodo di ricerca, di decisione e di scelta.
Troppo spesso l’orientamento è trattato come un progetto “extra”, un pacchetto di attività concentrate in alcuni momenti dell’anno: fiere universitarie, test attitudinali, incontri con esperti. In realtà, dovrebbe essere molto di più: una dimensione costitutiva della scuola.
L’ orientamento non può essere un’aggiunta occasionale, ma deve intrecciarsi con la didattica quotidiana, con i rapporti educativi, con il modo stesso di vivere l’esperienza scolastica. Significa che tutte le discipline, non solo alcune, possono contribuire a costruire strumenti orientativi: imparare a ragionare, ad analizzare, a collegare, a sbagliare e a ricominciare.
Come sottolinea Paola Parente, le traiettorie formative e professionali non sono lineari: cambiano i mestieri, cambiano le esigenze della società, e i giovani devono sviluppare la capacità di ri-immaginarsi, di ri-orientarsi lungo la vita. La scuola, se intende preparare al futuro deve insegnare prima di tutto a non temere la complessità. Anche i ragazzi e le ragazze devono comprendere che il percorso per conoscersi, decidere e scegliere è lungo, complesso e continuo.
Per lungo tempo abbiamo pensato all’orientamento come a un meccanismo per collocare le persone nel mercato del lavoro. Ma le persone non sono “risorse da incasellare”: sono individui con storie, sogni, fragilità e talenti nascosti.
Un orientamento che funzioni deve guardare prima di tutto all’umanità dei ragazzi e delle ragazze. Non si tratta di dire “questo non fa per te” o “non sei portato per questa materia”, ma di offrire strumenti per esplorare passioni, coltivare curiosità, sperimentare strade nuove. Troppo spesso l’orientamento è negativo: indica ciò che non si deve fare. Dobbiamo invece capovolgerlo e trasformarlo in un atto di fiducia.
L’adulto — insegnante, genitore, orientatore — non deve imporre soluzioni, ma accompagnare, stimolare domande, aprire possibilità. Orientare significa fare un passo indietro e lasciare che il ragazzo diventi protagonista delle proprie scelte. È un gesto di fiducia nella sua capacità di crescere, di imparare, di costruire sé stesso/a e si deve fare in modo che acquisisca gli strumenti per agire in autonomia e responsabilità.
Uno dei compiti più urgenti dell’orientamento è combattere gli stereotipi che limitano i ragazzi e, in particolare, le ragazze. Quante volte abbiamo sentito frasi come: “La matematica non è per le ragazze” oppure “Non sei portato per le materie scientifiche”. Sono messaggi impliciti e talvolta invisibili, che pesano come macigni e condizionano le scelte. Orientare significa anche smantellare questi pregiudizi, proporre modelli diversi, creare ambienti in cui il rischio, l’errore, la sperimentazione non siano vissuti come fallimenti, ma come parte normale della crescita. Solo così i ragazzi e le ragazze potranno sentirsi liberi di scegliere in base ai propri desideri e non alle aspettative esterne.
C’è una disciplina che più di altre può diventare una palestra di orientamento permanente: la matematica. Non è solo un insieme di formule e regole, ma un’esperienza di vita.
- Ogni problema ha più soluzioni: come nella vita, non c’è una sola strada, ma tante possibilità.
- L’errore è parte del percorso: in matematica si sbaglia spesso, e ogni errore diventa occasione per crescere. È una lezione di resilienza e di coraggio.
- Autonomia e creatività: imparare a dimostrare, a collegare concetti, a ragionare con rigore ma anche con fantasia è un allenamento prezioso per ogni scelta futura.
- Democrazia del sapere: la matematica non appartiene ai “geni”, non è privilegio di pochi. Tutti possono avvicinarsi alla matematica, e quindi tutti possono orientarsi con pari dignità.
Mi piace pensare alla scuola come a un albero, non come a una fabbrica. La fabbrica misura, standardizza, produce in serie. L’albero cresce con rami diversi, ognuno con la sua forma e direzione. L’orientamento non serve a uniformare, ma a nutrire i rami, a dare linfa perché ciascuno cresca nella propria direzione.
Paola Parente individua tre dimensioni fondamentali dell’orientamento: espressività, possibile, fattibile. Attraverso la matematica, possiamo declinarle così:
- Espressività: la matematica come linguaggio per raccontare se stessi, il proprio modo di ragionare, le proprie intuizioni.
- Possibile: la matematica apre campi molteplici — scienze, tecnologia, economia, arte — e permette di immaginare scenari futuri.
- Fattibile: grazie al metodo e alla perseveranza, trasforma i sogni in progetti concreti.
Così l’orientamento smette di essere un discorso astratto e diventa un esercizio quotidiano di pensiero e di immaginazione.
Ho sempre creduto che il coraggio e l’avere occhi per cercare nuove terre siano fondamentale per cercare il proprio posto nel mondo. Orientare non significa dire: “Sei bravo qui, quindi devi andare lì”, ma insegnare a non arrendersi, a credere nella possibilità di crescere, a non avere paura di riprovare.
La matematica, ancora una volta, è un’alleata: educa al pensiero critico, insegna a leggere dati e informazioni, aiuta a smascherare pregiudizi. È uno strumento di cittadinanza attiva, perché prepara a partecipare consapevolmente alla società.
In questo senso, l’orientamento diventa una bussola: non dice la strada da percorrere, ma aiuta a non perdersi, a scegliere con consapevolezza, a vivere la complessità senza esserne travolti.
Orientarsi oggi significa fidarsi di sé stessi. Non è decidere una volta per tutte, ma imparare a ri-orientarsi lungo la vita, senza smettere di interrogarsi su chi siamo e dove vogliamo andare.
La scuola, allora, non deve formare prodotti finiti, standardizzati, ma accompagnare ciascun ragazzo e ragazza a diventare ramo di un albero: forte, vitale, diverso, capace di crescere verso la propria direzione.
L’orientamento non è un lusso, né un passaggio obbligato: è una competenza vitale per affrontare il futuro. E la matematica, con la sua capacità di allenare al pensiero, all’errore, al coraggio, può diventare un laboratorio di orientamento permanente. Perché, in fondo, imparare a orientarsi significa imparare a vivere.