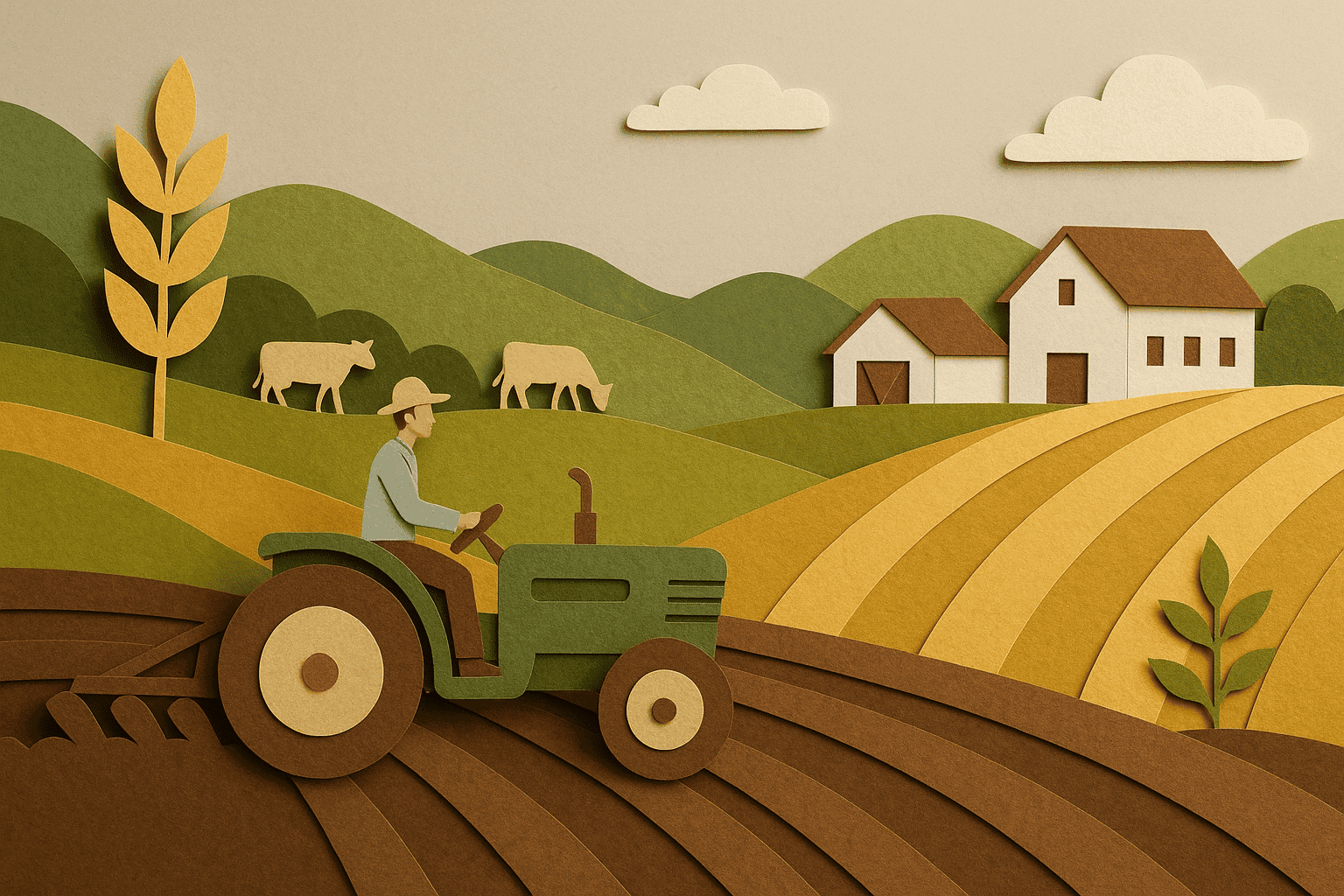Scegliere cosa fare dopo la scuola non è semplice. Serve tempo, informazioni, qualcuno che ti aiuti a vedere le possibilità. L’orientamento scolastico dovrebbe servire proprio a questo. Ma nella realtà, in tante scuole italiane, arriva quando è già tardi per scegliere davvero con calma.
A pochi mesi dalla maturità, quando il tempo è poco, lo stress è alto e le decisioni sono già alle porte, molti studenti ricevono per la prima volta informazioni su università, corsi, test d’ingresso o percorsi alternativi. Il risultato? Invece di chiarire le idee, l’orientamento finisce per sovraccaricare chi è già sotto pressione. Non c’è lo spazio per riflettere. Non c’è il tempo per esplorare. E spesso nemmeno la possibilità concreta di cambiare direzione.
Lo conferma anche il report Orientarsi dopo la scuola 2025, curato dal CISIA: più della metà degli studenti intervistati dichiara di aver partecipato ad attività di orientamento solo in quinta superiore. Molti di loro dicono chiaramente che è stato troppo tardi. Che avrebbero voluto iniziare prima, in quarta o addirittura in terza. Perché scegliere richiede tempo. E il tempo, quando l’orientamento arriva all’ultimo momento, non c’è più.
In questo articolo analizziamo il problema della tempistica sbagliata: perché l’orientamento post-diploma arriva quando è già difficile fermarsi a pensare, e cosa si potrebbe fare per invertire questa logica. Perché non è solo una questione di contenuti, ma di quando quei contenuti vengono proposti. E se si vuole davvero aiutare gli studenti a scegliere con consapevolezza, bisogna partire prima. Molto prima.
Quinta superiore: troppo piena per scegliere bene
La quinta superiore è un anno intenso. Programmi da chiudere, verifiche finali, la maturità che si avvicina, e in molti casi anche la preparazione ai test d’ingresso universitari. È un periodo carico di aspettative, scadenze, pressioni. In questo contesto, per moltissimi studenti, l’orientamento arriva all’improvviso, quando lo spazio per riflettere è già occupato da altro.
Il report Orientarsi dopo la scuola 2025 lo evidenzia chiaramente: la maggior parte delle attività orientative si concentra nell’ultimo anno. Per il 54% degli intervistati, le esperienze di orientamento sono iniziate e finite in quinta. E spesso si sono limitate a incontri informativi o presentazioni generiche, inserite nel calendario quando ormai la scelta è urgente. In queste condizioni, l’orientamento rischia di trasformarsi in un elenco di opzioni, più che in un vero percorso di esplorazione. Si raccolgono informazioni, si confrontano corsi, si valutano gli atenei. Ma manca il tempo per capire davvero cosa interessa, cosa motiva, cosa può funzionare per sé.
Molti studenti raccontano di aver scelto in fretta, con l’ansia di dover decidere. Altri hanno seguito l’onda: quello che fanno gli amici, quello che “suona bene”, quello che sembra più sicuro. Alcuni hanno lasciato perdere del tutto: troppo stress, troppa incertezza, troppe cose da fare tutte insieme. Il problema non è solo organizzativo. È culturale. C’è l’idea che la scelta del “dopo” si debba fare proprio in quel momento, a ridosso dell’esame, come se fosse una tappa automatica del percorso scolastico. Ma la verità è che la quinta è uno dei momenti peggiori per orientarsi bene. Troppo piena, troppo compressa, troppo carica di aspettative per lasciare spazio a una riflessione autentica e profonda.
E non basta “fare orientamento” in quinta. Se è la prima volta che uno studente si trova a pensare davvero al proprio futuro, è già in ritardo. L’orientamento, per funzionare, deve arrivare prima. Quando c’è ancora tempo per pensare, per sbagliare, per cambiare idea.
Quando sarebbe il momento giusto?
Secondo la maggior parte degli studenti e delle studentesse intervistati nel report, l’orientamento scolastico non dovrebbe iniziare in quinta. Dovrebbe iniziare molto prima. Il 43% di loro indica la quarta superiore come il momento ideale per cominciare a orientarsi. Un altro 29% si spinge oltre: sarebbe meglio iniziare già in terza. Solo una minoranza pensa che la quinta sia il momento giusto. E quasi nessuno ha trovato utile iniziare l’orientamento solo nei mesi finali dell’ultimo anno.
Questi dati dicono una cosa semplice ma importante: scegliere richiede tempo. Non si tratta solo di raccogliere informazioni, ma di costruire consapevolezza, esplorare possibilità, capire cosa può funzionare per sé. E questo processo non può essere compresso in poche settimane. Iniziare prima significa avere margine per:
- conoscere percorsi di studio e lavoro senza l’urgenza di decidere subito;
- confrontarsi con docenti, tutor, orientatori;
- cambiare idea, anche più volte, senza sentirsi in colpa o in ritardo;
- vivere l’orientamento come un’occasione per conoscersi, non come un’altra scadenza da rispettare.
Non vuol dire costringere uno studente di terza o quarta a “decidere tutto in anticipo”. Vuol dire dargli lo spazio per iniziare a porsi domande, per provare a immaginarsi in un futuro possibile, senza la pressione del “scegli ora o è troppo tardi”.
Anticipare l’orientamento non è solo una questione di calendario. È una questione di qualità della scelta. Più tempo significa più possibilità di fare una scelta informata, ragionata, personale. Meno tempo significa più rischio di affidarsi al caso, all’imitazione, alla paura di sbagliare. Se chiediamo agli studenti quando avrebbero voluto ricevere supporto, la risposta è chiara: non quando tutto sta già finendo, ma quando si ha ancora il tempo di guardare avanti con lucidità.
Orientamento come processo, non come evento
Quando si parla di orientamento scolastico, spesso si pensa a una giornata, una presentazione, un laboratorio. Un momento isolato, che accade una volta all’anno – o forse una volta soltanto – e che dovrebbe bastare a chiarire le idee su cosa fare “dopo”. Ma orientarsi non funziona così. Non si tratta di ascoltare qualcuno che ti spiega cosa puoi fare. Si tratta di mettere insieme pezzi diversi nel tempo, di farsi domande, raccogliere esperienze, confrontarsi, cambiare prospettiva. In altre parole, di vivere un percorso, non un evento.
Anche questo emerge con forza dal report Orientarsi dopo la scuola 2025: gli studenti che hanno vissuto l’orientamento come qualcosa di continuativo – distribuito su più anni, con tappe diverse – dichiarano una maggiore sicurezza nella scelta e una maggiore consapevolezza delle alternative disponibili. Chi invece ha avuto un’esperienza concentrata in poche ore o in un solo incontro, spesso la definisce confusa, generica, insufficiente.
Per questo parlare solo di “iniziare prima” non basta. L’orientamento non va solo anticipato, ma spalmato nel tempo, pensato come un accompagnamento che cresce con lo studente. Un percorso che inizia con l’esplorazione, prosegue con momenti di confronto, include esperienze pratiche e lascia spazio alla revisione delle proprie idee.
Un errore diffuso: pensare che l’orientamento si risolva in un’informativa
Molti studenti raccontano che l’unico momento dedicato all’orientamento è stato un incontro informativo con una persona esterna, magari poco coinvolgente o distante dal loro vissuto. Oppure una serie di Open Day o brochure da consultare in autonomia, senza un vero supporto. Queste attività possono essere utili, certo, ma non bastano a costruire una scelta consapevole. Senza un contesto in cui inserirle, senza un percorso che aiuti a dare senso a quelle informazioni, rischiano di aggiungere solo altro rumore.
Un processo serve anche a sbagliare (prima di decidere)
Un orientamento pensato come processo permette anche un’altra cosa fondamentale: sbagliare in tempo. Provare un laboratorio e rendersi conto che non interessa. Ascoltare una testimonianza e capire che non ci si riconosce. Sono passi utili, se fatti con margine. Ma quando tutto avviene in quinta, spesso non c’è più tempo per rimettere in discussione nulla.
In sintesi, il problema non è solo che l’orientamento arriva tardi. È che arriva male: come evento isolato, privo di continuità, senza un disegno coerente. E quando si tratta di scegliere il proprio futuro, questo approccio non basta più. Servono percorsi lunghi, strutturati, pensati per evolvere nel tempo. Solo così si può parlare davvero di orientamento. Tutto il resto è una corsa contro il tempo.
Cosa succede quando si sceglie tardi (e male)
Scegliere all’ultimo momento non è solo più difficile. È anche più rischioso. Quando l’orientamento arriva tardi, e la decisione va presa in fretta, molti studenti non scelgono davvero: seguono l’onda, si affidano al caso, oppure decidono di non decidere. È così che tanti si iscrivono a un corso universitario che non conoscono bene, che non li convince del tutto, che pensano sia “utile” anche se non li appassiona. Altri scelgono di non iscriversi affatto, non per convinzione, ma per confusione o sfiducia. E altri ancora si prendono un anno sabbatico che non avevano programmato, e che spesso si trasforma in un limbo da cui è difficile uscire.
Secondo i dati del report:
- molti studenti dichiarano di aver fatto una scelta senza avere un quadro completo delle alternative disponibili;
- alcuni ammettono di non aver capito cosa significasse davvero quel percorso fino a quando non lo hanno iniziato;
- diversi raccontano di aver cambiato idea dopo pochi mesi, sentendosi però “in colpa” o “in ritardo”.
Queste storie non sono eccezioni. Sono segnali di un problema diffuso: orientarsi male, o troppo tardi, ha conseguenze reali.
Le conseguenze più comuni di una scelta affrettata
- Iscrizioni impulsive, basate su nomi noti, mode del momento o pressioni esterne.
- Alti tassi di abbandono nei primi mesi di università, spesso accompagnati da senso di frustrazione o fallimento.
- Scelte condizionate dal contesto, più che da interessi personali o attitudini: quello che fanno gli amici, quello che si conosce per caso, quello che si “pensa di poter fare”.
- Percorsi interrotti o cambiati, con perdita di tempo, denaro e fiducia.
- Rinuncia a continuare gli studi, anche quando ci sarebbero le capacità, per mancanza di direzione.
In molti casi, questi esiti non dipendono da una reale incompatibilità tra studente e percorso scelto. Dipendono dal modo in cui quella scelta è avvenuta: in fretta, con poche informazioni, in un momento sbagliato.
Il prezzo della non-scelta
C’è poi un altro effetto meno visibile ma altrettanto pesante: la non-scelta. Quando nessuno ti accompagna a esplorare, quando non c’è tempo per riflettere, quando ti senti già in ritardo, la tentazione di non scegliere affatto è forte. Si rimanda. Si lascia perdere. Si spera che qualcosa succeda.
Secondo il report, tra chi non ha proseguito gli studi dopo il diploma, molti dichiarano che un orientamento fatto prima e meglio li avrebbe aiutati a fare una scelta diversa. Ecco perché la tempistica dell’orientamento non è un dettaglio tecnico o organizzativo. È una delle variabili che più incidono sul futuro di migliaia di ragazze e ragazzi. Se si arriva troppo tardi, si sceglie peggio. O non si sceglie affatto. E a quel punto, è molto più difficile recuperare.
Il ruolo (spesso sottovalutato) della quarta superiore
La quarta superiore è quasi sempre il grande assente quando si parla di orientamento. Troppo presto per molti, troppo tardi per iniziare a pensare in grande. Eppure, se c’è un momento che potrebbe fare davvero la differenza, è proprio questo. Non c’è ancora la pressione della maturità, dei test d’ingresso, delle scadenze imminenti. Gli studenti sono abbastanza grandi per iniziare a interrogarsi seriamente sul futuro, ma non così vicini al diploma da sentirsi in trappola. È il momento ideale per seminare, esplorare, aprire possibilità. Ma nella pratica, in troppe scuole, non succede nulla di tutto questo.
Perché la quarta è il momento giusto
Nel report Orientarsi dopo la scuola 2025, quasi la metà degli studenti indica proprio la quarta come il momento in cui avrebbe voluto iniziare a orientarsi. Non per decidere subito, ma per avere tempo. Tempo per informarsi senza fretta. Per conoscere percorsi alternativi. Per scoprire che ci sono tante strade possibili. E per fare tutto questo senza l’ansia della scelta imminente.
Anticipare all’ultimo biennio non significa obbligare a scegliere prima. Significa creare un contesto in cui la scelta matura gradualmente, accompagnata da stimoli, confronti, esperienze. E la quarta è l’anno in cui questo accompagnamento può iniziare in modo naturale, senza forzature.
Cosa si potrebbe fare, concretamente
Un orientamento serio in quarta non ha bisogno di grandi eventi o interventi eccezionali. Basterebbero azioni semplici, regolari, coerenti, che aiutino gli studenti a costruire domande, non solo a cercare risposte. Alcuni esempi:
- Laboratori di scoperta delle attitudini e degli interessi, anche in orario scolastico.
- Incontri con ex studenti che raccontino il loro percorso dopo il diploma, tra scelte riuscite e ripensamenti.
- Momenti di confronto guidato tra pari, per riflettere sulle aspettative e sulle paure legate al futuro.
- Prime esperienze con il mondo del lavoro o dell’università, anche solo attraverso visite o testimonianze.
- Spazi per raccogliere domande, anche senza dare subito risposte.
Il punto non è fornire informazioni a pioggia, ma aprire uno spazio di ascolto e ricerca. Farlo in quarta significa dare agli studenti il tempo per capire e per cambiare idea, senza sentirsi già in ritardo.
La quarta come ponte, non come anticipo forzato
Uno dei rischi, quando si parla di anticipare l’orientamento, è pensare che significhi accelerare la scelta. Ma la quarta non deve diventare un nuovo punto di arrivo. Deve diventare un ponte tra la scuola e il dopo, un momento in cui cominciare a costruire la propria direzione, senza obbligo di definire tutto.
Non tutti saranno pronti nello stesso momento. Ma tutti devono avere la possibilità di iniziare prima che sia troppo tardi. E se l’orientamento serve ad accompagnare chi è in cammino, la quarta superiore è il momento in cui quel cammino può iniziare davvero.
Chi decide quando farlo? Le scuole lasciate sole
Un aspetto spesso sottovalutato, ma fondamentale per capire perché l’orientamento in Italia arriva nel momento sbagliato, riguarda l’organizzazione stessa delle attività. Chi stabilisce quando iniziare a orientare gli studenti? Con quali modalità? Con quale frequenza?
La risposta, purtroppo, è semplice: dipende dalla singola scuola. Non esiste un modello condiviso, né un obbligo di seguire tempi precisi. Ogni istituto si regola come può. O come riesce. E così succede che in alcune scuole superiori le attività di orientamento comincino già in terza, con percorsi progressivi ben costruiti, mentre in altre si riducano a un paio di ore in quinta, inserite tra una lezione e l’altra, senza reale continuità. Non è una questione di buona volontà. Spesso è una questione di risorse, di tempo, di personale.
L’orientamento affidato al caso
Questa discrezionalità genera una disuguaglianza strutturale: l’accesso a un orientamento efficace e tempestivo dipende dal codice meccanografico della tua scuola. Se sei in un istituto che ha investito nell’orientamento, inizi prima, fai esperienze, incontri tutor, visiti università. Se sei in una scuola che non ha tempo, fondi, o competenze specifiche, puoi arrivare alla maturità senza aver ricevuto nulla di concreto. È un sistema che lascia troppo spazio all’improvvisazione. E in un momento così delicato come quello della scelta post-diploma, non può essere il caso a decidere chi riceve supporto e chi no.
Una questione di responsabilità
Il report CISIA lo segnala senza mezzi termini: servono indicazioni più chiare e vincolanti, non solo sui contenuti dell’orientamento, ma anche sui tempi e sulle modalità di erogazione.
L’attuale autonomia scolastica, per quanto importante, non può giustificare disparità così profonde nell’accesso alle stesse opportunità.
Un esempio concreto? Nel report, molti studenti dichiarano che la loro scuola ha offerto attività di orientamento solo su richiesta individuale, oppure solo per chi voleva proseguire all’università. E chi non aveva già le idee chiare? Chi avrebbe avuto bisogno proprio di un supporto all’inizio, e non alla fine? È rimasto fuori.
L’urgenza di una cornice comune
Per evitare che l’orientamento resti un’esperienza “a macchia di leopardo”, servono:
- tempi minimi garantiti, distribuiti su più anni;
- linee guida vincolanti, che non si limitino a raccomandazioni generiche;
- strumenti comuni di monitoraggio, per valutare davvero cosa funziona e cosa no;
- risorse dedicate e stabili, che non costringano le scuole a inventare ogni anno da zero.
Fino a quando tutto sarà lasciato all’iniziativa delle singole scuole, non ci sarà mai un orientamento davvero equo, né efficace. E continueremo ad avere studenti che scelgono tardi, male, o non scelgono affatto. Non per mancanza di interesse. Ma perché nessuno ha pensato di accompagnarli per tempo.
Il valore della gradualità: l’orientamento come allenamento alla scelta
Scegliere non è un gesto istantaneo. Non basta “sapere cosa c’è” per decidere. Serve tempo, maturazione, confronto, ripensamento. E soprattutto serve allenarsi a scegliere. Un po’ alla volta. Invece, oggi, l’orientamento scolastico somiglia spesso a una corsa contro il tempo. Tante informazioni concentrate in poche settimane. Una decisione da prendere in fretta. E la sensazione, per molti studenti, di non essere pronti a farlo.
Ma la capacità di scegliere non nasce sotto pressione. Si costruisce nel tempo, proprio come un muscolo. E questo è il grande valore della gradualità: offrire agli studenti occasioni di confronto progressivo con il tema della scelta, senza pretendere che abbiano già tutte le risposte.
Orientarsi vuol dire conoscersi (e serve tempo)
Nel report Orientarsi dopo la scuola 2025, molti studenti dichiarano che l’orientamento è stato utile non tanto per sapere cosa fare, ma per capire meglio se stessi. Questo è un passaggio essenziale, ma che richiede spazio e continuità. Non si può pensare che un ragazzo o una ragazza trovi chiarezza su sé stesso in due incontri all’ultimo anno. Serve prima esplorare le proprie attitudini, riflettere su interessi e valori, conoscere percorsi che fino a quel momento non si erano nemmeno immaginati. E magari anche provare, sbagliare, cambiare idea. Tutto questo ha bisogno di gradualità. Non di urgenza.
Allenarsi alla scelta, non solo decidere
Un orientamento ben fatto non serve solo a prendere una decisione immediata. Serve ad allenarsi a prendere decisioni nella vita, a gestire l’incertezza, a valutare scenari possibili, a convivere con il dubbio. È una competenza trasversale, che serve non solo per l’università, ma per il lavoro, le relazioni, i percorsi futuri. Se si abitua lo studente a riflettere sulle scelte sin dalla terza o quarta superiore, non sarà spiazzato quando dovrà decidere davvero. Se invece lo si lascia “al buio” fino all’ultimo, è molto più probabile che la decisione sia forzata, frettolosa o passiva.
Evitare il picco di ansia finale
Un orientamento distribuito nel tempo aiuta anche a contenere l’ansia, che nella quinta superiore tende a raggiungere livelli altissimi. Quando tutto viene concentrato in pochi mesi, si crea un sovraccarico emotivo: la sensazione che il futuro si giochi tutto lì, in quel momento, con una decisione da cui non si torna indietro. In realtà, nessuna scelta è definitiva. Ma se l’orientamento arriva solo alla fine, sembra esserlo. E questo genera blocchi, paure, rinunce.
Scegliere è un processo, non un quiz
Il modello implicito che spesso passa nelle scuole è questo: a un certo punto dovrai “indovinare” cosa fare, come se ci fosse una risposta esatta. Ma non si tratta di trovare la risposta giusta. Si tratta di costruire la risposta più adatta a sé, in quel momento. Un percorso di orientamento graduale, che accompagna nel tempo, aiuta gli studenti a costruire senso, non solo a dare risposte. E questa è la vera differenza tra chi affronta il futuro con consapevolezza e chi lo subisce.
E se cominciassimo già alle medie?
Per molti può sembrare presto. Forse troppo presto. Eppure, sempre più esperti e insegnanti pongono una domanda che merita attenzione: ha senso parlare di orientamento solo dopo i 16 anni? O non sarebbe più utile cominciare già durante le scuole medie, in modo graduale e adatto all’età?
Non si tratta di chiedere a un tredicenne di scegliere cosa farà da grande. Ma di iniziare a costruire le basi dell’orientamento: conoscenza di sé, esplorazione degli interessi, curiosità verso ciò che c’è “là fuori”. In altre parole, seminare prima, per raccogliere con più consapevolezza in futuro.
Perché ha senso iniziare prima
Alle scuole medie, gli studenti iniziano a porsi domande importanti: chi sono? In cosa sono bravo? Cosa mi piace fare? Cosa mi annoia? Come immagino il mio futuro? Sono domande semplici, a volte confuse, ma fondamentali. E sono proprio queste le domande da cui dovrebbe partire l’orientamento. Se restano inascoltate o lasciate alla spontaneità, si rischia di arrivare alle superiori senza strumenti minimi per affrontare le scelte successive.
In più, è proprio alle medie che si affronta la prima vera scelta scolastica: liceo, tecnico, professionale. Una scelta che, anche se spesso sottovalutata, condiziona fortemente il percorso successivo. E che molti studenti fanno ancora in modo disinformato, seguendo logiche familiari, territoriali o casuali.
Non orientamento precoce, ma precoce alfabetizzazione alla scelta
È importante essere chiari: non si tratta di anticipare decisioni, ma di sviluppare precocemente le competenze utili a scegliere. Un’“alfabetizzazione all’orientamento”, potremmo chiamarla così. Per esempio:
- imparare a riconoscere i propri punti di forza e le proprie difficoltà;
- sperimentare attività diverse, anche pratiche e creative;
- ascoltare storie di lavoro e di studio, senza giudizi o pressioni;
- esplorare in modo giocoso il concetto di futuro;
- capire che la scelta non è una scommessa, ma un percorso da costruire.
Alcune sperimentazioni già esistono
In alcune regioni italiane sono già attivi progetti di orientamento precoce nelle scuole secondarie di primo grado. Esperienze pilota che introducono attività leggere ma significative, con risultati promettenti: maggiore consapevolezza nella scelta della scuola superiore, più motivazione, meno abbandoni scolastici.
Anche il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha previsto un rafforzamento dell’orientamento a partire dalla scuola media, ma l’attuazione è ancora molto disomogenea. Per molti docenti e dirigenti, manca una visione chiara di cosa significhi fare orientamento “prima”, e soprattutto mancano risorse, formazione e continuità.
Una scommessa culturale, non solo educativa
Cominciare a parlare di orientamento già alle medie richiede un cambio di prospettiva. Significa smettere di pensare alla scelta come a un punto d’arrivo, e iniziare a vederla come un processo di crescita personale.
Non è questione di anticipare tutto, ma di creare le condizioni per scegliere meglio quando sarà il momento. E questo può succedere solo se si comincia a costruire prima, con cura, con misura e con fiducia nelle potenzialità di ogni studente.
Il momento giusto per scegliere è prima, non dopo
Il problema non è solo che l’orientamento arrivi tardi. Il problema è che arriva quando non c’è più tempo per farlo bene. Lo dice il report Orientarsi dopo la scuola 2025, lo confermano i dati, lo raccontano migliaia di studenti: scegliere sotto pressione, all’ultimo minuto, senza uno spazio vero per riflettere, non funziona. E non perché i ragazzi non siano capaci di scegliere. Ma perché non li stiamo mettendo nelle condizioni giuste per farlo.
La quinta superiore è troppo piena. La quarta è il momento ideale. Le medie sono un’opportunità sottovalutata. E in tutto questo, le scuole sono spesso lasciate sole, senza una direzione comune, senza strumenti continui, senza tempo. Serve un cambio di passo. Serve un orientamento pensato come processo, non come evento. Un percorso che comincia presto, si sviluppa nel tempo, si adatta all’età e al contesto. Che non dia solo risposte, ma aiuti a farsi domande. Che non si limiti a “informare”, ma accompagni a scegliere. Perché la scelta del futuro non è mai un gesto automatico. È una costruzione lenta, fatta di incontri, esperienze, errori e intuizioni.
E se vogliamo davvero che ogni studente possa arrivarci pronto, libero, consapevole, dobbiamo cominciare prima. Non dopo, quando tutto è già deciso. Non all’ultimo, quando ormai si ha fretta. Il momento giusto per scegliere è prima. Sempre. E costruire un orientamento che lo permetta non è un lusso. È una necessità educativa.