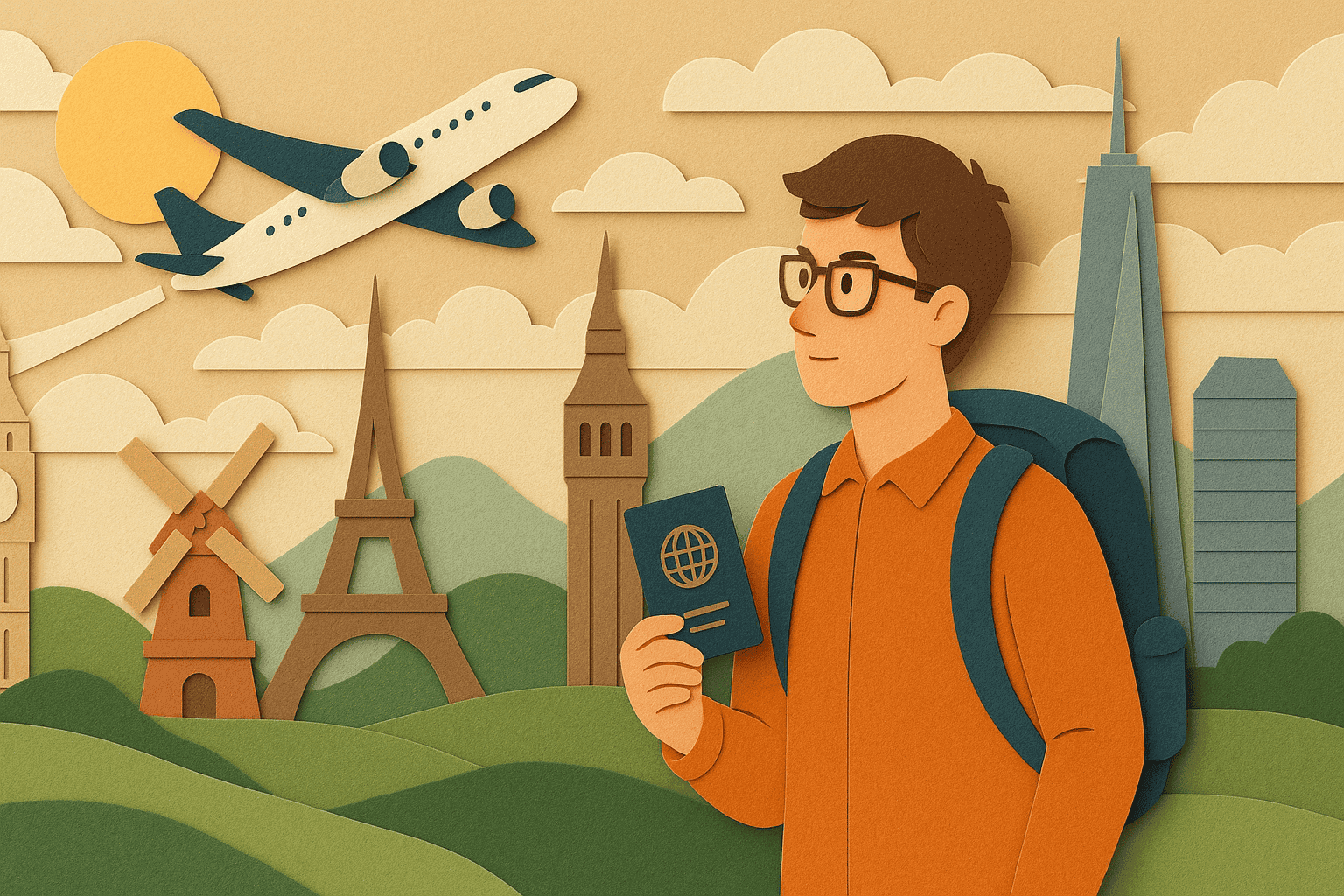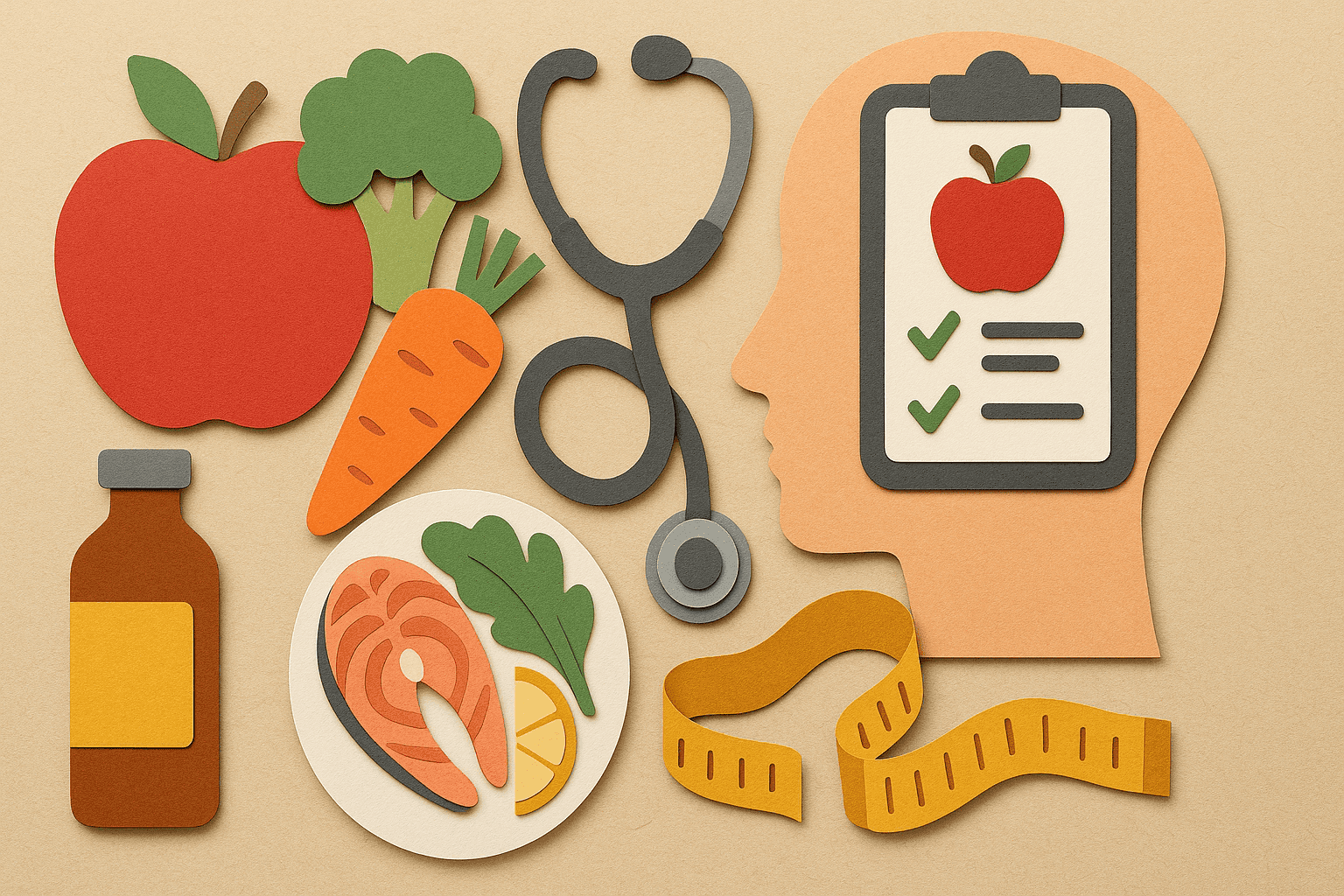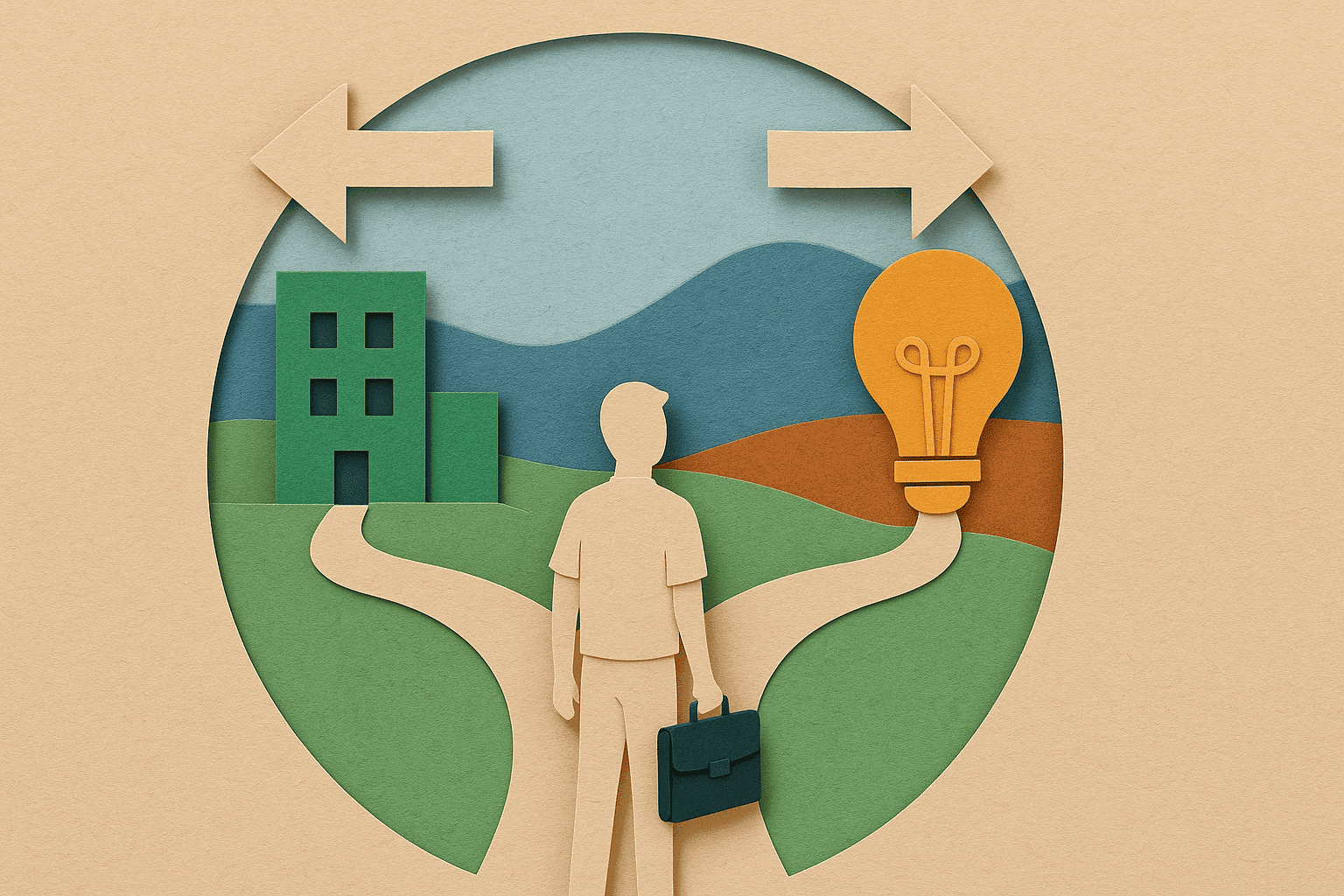In un mercato del lavoro sempre più incerto, capire quali professioni stanno nascendo, quali stanno cambiando e quali stanno lentamente scomparendo è diventato essenziale, sia per chi deve scegliere un percorso di studi sia per chi sta pensando di cambiare lavoro. Ma dove trovare informazioni affidabili e aggiornate? Uno degli strumenti più utili in questo senso è l’Atlante delle Professioni, un progetto sviluppato dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea insieme all’Università di Torino, che da anni mappa e analizza l’evoluzione delle professioni in Italia.
L’Atlante non si limita a elencare i mestieri esistenti, ma li descrive in modo dettagliato: per ciascuna professione indica le attività principali, le competenze richieste, i contesti in cui si esercita, i percorsi formativi consigliati e le tendenze occupazionali. È uno strumento pensato per aiutare studenti, lavoratori e orientatori a leggere il mondo del lavoro con uno sguardo aggiornato e realistico.
L’edizione 2025 è particolarmente interessante perché si concentra su un periodo di grandi trasformazioni. Sotto la spinta della digitalizzazione, della transizione ecologica e dei cambiamenti demografici, molte professioni stanno evolvendo rapidamente, mentre ne emergono di nuove, spesso ibride e trasversali. Non si tratta solo di nomi nuovi, ma di ruoli che rispondono a bisogni inediti della società e richiedono competenze diverse rispetto al passato. In questo scenario, l’Atlante diventa una bussola preziosa per orientarsi. In questo articolo, proviamo a leggere insieme i principali segnali di cambiamento che emergono dal documento: quali sono le professioni del futuro, perché stanno crescendo proprio ora, cosa cambia rispetto a dieci anni fa e quali competenze conviene sviluppare per restare al passo.
Le professioni verdi: dal tecnico ambientale all’ingegnere della sostenibilità
La transizione ecologica non è più un obiettivo distante, ma una realtà concreta che sta trasformando il mondo del lavoro. Le professioni legate alla sostenibilità sono oggi tra le più richieste, soprattutto nei settori dell’energia, dell’edilizia, dell’agricoltura e della mobilità. Alcune figure stanno diventando centrali nei processi di innovazione ambientale.
Un esempio è il tecnico per l’efficienza energetica degli edifici, che si occupa di valutare i consumi, proporre interventi di riqualificazione e integrare fonti rinnovabili. Oppure il mobility manager, una figura sempre più presente nelle aziende e nelle amministrazioni pubbliche, che pianifica soluzioni di trasporto sostenibile per dipendenti e cittadini. In ambito industriale cresce il ruolo del responsabile ambientale, che monitora l’impatto delle attività produttive e propone strategie per ridurre emissioni e sprechi. Altre figure emergenti includono il project manager per la sostenibilità, che coordina progetti in linea con i criteri ESG (ambientali, sociali e di governance), e l’ingegnere ambientale specializzato in materiali innovativi, capace di progettare soluzioni a basso impatto per l’edilizia e il packaging.
In agricoltura si stanno diffondendo ruoli come il consulente per l’agroecologia o il tecnico per l’agricoltura di precisione, che applicano tecnologie avanzate per ridurre l’uso di acqua, fertilizzanti e pesticidi. Anche il settore forestale sta evolvendo, con la richiesta di gestori di servizi ecosistemici che sappiano coniugare tutela ambientale e sviluppo economico locale. Queste professioni non sono riservate solo a laureati in ingegneria o scienze ambientali. In molti casi, si tratta di ruoli accessibili anche con percorsi tecnici post-diploma o con corsi di formazione professionale, purché aggiornati alle nuove competenze richieste.
Le professioni del digitale: quando la tecnologia incontra i bisogni reali
Il digitale non è più un settore a sé, ma una trasformazione trasversale che tocca ogni ambito della vita quotidiana. Per questo, le figure professionali più richieste oggi non sono solo esperti di codice, ma persone in grado di applicare le tecnologie digitali a contesti concreti: dalla salute alla scuola, dalla pubblica amministrazione alla cultura.
Una delle professioni più ricercate è quella del data analyst, cioè l’esperto che raccoglie, interpreta e restituisce in modo comprensibile i dati, aiutando aziende, enti pubblici e organizzazioni a prendere decisioni più consapevoli. Accanto a lui lavora spesso il data engineer, che costruisce le infrastrutture tecnologiche per gestire grandi quantità di dati.
In un’epoca in cui le minacce informatiche crescono, le aziende cercano con urgenza cybersecurity specialist, esperti nella protezione di reti, sistemi e dati sensibili. Queste figure sono fondamentali non solo nel settore bancario o governativo, ma anche in ospedali, scuole e aziende private. Altro ambito in forte crescita è quello dell’intelligenza artificiale. Si cercano machine learning developer, che progettano algoritmi capaci di “imparare” dai dati, ma anche AI ethicist, professionisti in grado di valutare l’impatto etico delle tecnologie intelligenti.
Una figura più trasversale e sempre più centrale è quella del UX designer (user experience designer), che progetta interfacce digitali pensando all’esperienza dell’utente: un mestiere che unisce psicologia, design, accessibilità e tecnologia. Dai portali pubblici alle app per la salute, ogni servizio digitale ha bisogno di essere comprensibile e utilizzabile da tutti.
Ma il digitale non è solo sviluppo e sicurezza. Cambia anche il lavoro di chi si occupa di contenuti e comunicazione. Il redattore o il giornalista di oggi deve saper dialogare con gli algoritmi, leggere gli insight, ottimizzare testi per i motori di ricerca o per i social, capire come e dove circolano le informazioni. Nascono così ruoli come il digital content strategist, lo specialista in comunicazione scientifica digitale o il community manager.
Oggi le competenze digitali non sono appannaggio solo degli specialisti, ma diventano essenziali anche in ruoli “ibridi”, dove tecnologia e umanità si incontrano. E in molti casi, ciò che fa la differenza non è la conoscenza tecnica pura, ma la capacità di adattare gli strumenti alle persone e ai loro bisogni.
Intelligenza artificiale e lavoro: cosa cambia davvero?
L’intelligenza artificiale non cancellerà il lavoro umano, ma lo cambierà in profondità. L’Atlante delle Professioni 2025 evidenzia che non è tanto la “professione” in sé a essere a rischio, quanto alcune attività all’interno delle professioni, specialmente quelle più ripetitive o automatizzabili. Il cambiamento riguarda quindi la struttura del lavoro, non solo la sua esistenza.
Le professioni più esposte all’automazione sono quelle che prevedono compiti standardizzati, prevedibili e facilmente replicabili da una macchina. Ad esempio, la gestione base di dati, l’inserimento di informazioni, alcune forme di customer service o la produzione di contenuti generici. Al contrario, sono meno sostituibili le attività che richiedono pensiero critico, creatività, empatia, capacità relazionali o decisioni complesse in contesti incerti.
Per questo, l’Atlante suggerisce di spostare l’attenzione dalle “professioni” alle “competenze”. Le persone che sapranno affiancare l’intelligenza artificiale invece di temerla, integrandola nel proprio lavoro, avranno un vantaggio competitivo. E questo vale sia per figure tecniche, come sviluppatori o data scientist, sia per professioni educative, sanitarie, sociali o creative. In pratica, non è necessario diventare tutti esperti di AI, ma è utile comprenderne le logiche di base, saperla utilizzare come strumento e restare aggiornati sulle sue applicazioni nel proprio ambito. In futuro, anche professioni molto umane – come l’insegnante, il medico o il giornalista – potrebbero collaborare quotidianamente con sistemi intelligenti per potenziare il proprio lavoro.
Secondo il rapporto INAPP 2024, l’impatto delle AI sul lavoro sarà uno dei temi centrali del cambiamento tecnologico nel mercato del lavoro. Molte professioni del futuro non saranno sostituite dalla tecnologia, ma nasceranno proprio per gestirla, adattarla e renderla utile e comprensibile alle persone. Un esempio concreto è il crescente bisogno di AI trainer, esperti in etica dell’algoritmo, traduttori tra tecnico e non tecnico, capaci di fare da ponte tra macchine e umani.
Le nuove professioni della cura: tra sanità, territorio e comunità
L’area dei servizi alla persona è una delle più dinamiche del mercato del lavoro, spinta da due grandi trasformazioni sociali: l’invecchiamento della popolazione e la crescente complessità dei bisogni educativi, sociali e psicologici. Non si tratta solo di un aumento numerico della domanda, ma di una profonda evoluzione del ruolo stesso dei professionisti della cura.
Tra le figure più richieste c’è l’infermiere di comunità, una professione che esisteva anche in passato ma che oggi assume un ruolo più centrale. Non lavora solo in ospedale, ma segue i pazienti sul territorio, nelle case, nelle RSA, promuovendo la prevenzione e il monitoraggio delle patologie croniche. A questa figura si affianca il care manager, un profilo emergente che coordina i percorsi di assistenza personalizzata per pazienti fragili o anziani, spesso integrando servizi sanitari, sociali e familiari.
Nel campo della riabilitazione, crescono le richieste di fisioterapisti, ma anche di logopedisti e terapisti occupazionali, specializzati nella gestione di patologie croniche, neurodegenerative o dello sviluppo. La novità è che queste figure lavorano sempre più spesso in équipe multidisciplinari, con competenze anche digitali per usare strumenti di teleassistenza, cartelle elettroniche e programmi riabilitativi a distanza.
Anche nell’area educativa e sociale, le professioni stanno cambiando volto. L’educatore professionale socio-pedagogico è sempre più richiesto in contesti scolastici, comunità per minori, servizi di sostegno alla genitorialità, centri per la disabilità. A lui si affianca la figura dell’educatore specializzato in bisogni educativi complessi, capace di intervenire in situazioni ad alto rischio sociale o psicologico, spesso in collaborazione con psicologi e assistenti sociali. L’assistente sociale di oggi non si occupa solo di pratiche amministrative, ma è coinvolto in progetti di intervento sul territorio, in stretta connessione con le istituzioni, le famiglie e le associazioni. Deve conoscere le reti di supporto locali, saper comunicare con efficacia e gestire situazioni di vulnerabilità con competenze organizzative e relazionali.
Infine, cresce anche il ruolo dello psicologo nei servizi pubblici e nel terzo settore, non più solo per la clinica individuale, ma per interventi nelle scuole, nelle aziende, nelle carceri e nei percorsi di salute mentale comunitaria. Il concetto di cura oggi è più ampio e integrato: si prende in carico la persona nella sua interezza, anche nel contesto sociale in cui vive.
Rispetto a dieci anni fa, queste professioni richiedono competenze nuove, tra cui la capacità di lavorare in rete, usare strumenti digitali, comunicare in modo efficace con utenti di età, culture e fragilità diverse. Il lavoro di cura si è spostato sempre più verso il territorio e la comunità, diventando più vicino alla vita reale delle persone.
Orientarsi in un mondo del lavoro che cambia così in fretta può sembrare scoraggiante, ma oggi esistono strumenti validi per leggere il presente e prepararsi al futuro. L’Atlante delle Professioni è uno di questi: un punto di partenza per chi cerca ispirazione, per chi vuole cambiare rotta o semplicemente capire come evolvere nel proprio settore. La chiave non è inseguire mode, ma capire quali competenze stanno diventando centrali e come possono intrecciarsi con ciò che già sappiamo fare. Per restare rilevanti, spesso non serve ricominciare da capo: basta imparare a muoversi, passo dopo passo, in una direzione nuova.