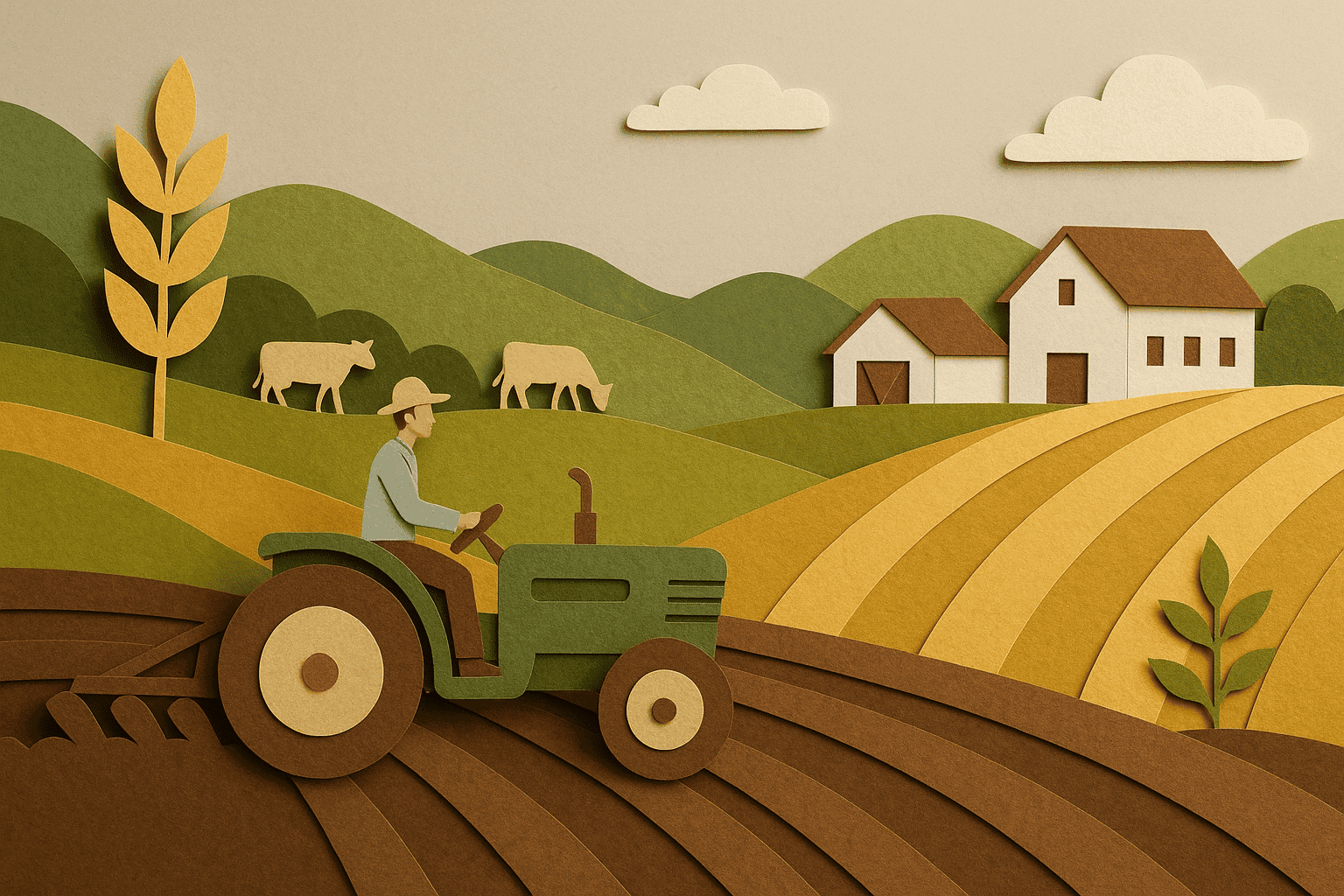Capirlo è un lavoro vero, serio. Serve tempo, spazio, fiducia. Serve chi ti ascolta senza giudicarti. Non bastano le statistiche sull’occupazione post-diploma, né i test attitudinali standardizzati. Serve costruire un cammino che parta da te.
Per fortuna, ci sono figure professionali che questa cosa la sanno. Insegnanti, counselor e psicologi sono i tre pilastri del lavoro di orientamento. Ma se vogliamo fare un salto di qualità, dobbiamo smettere di trattarli come compartimenti stagni. Dobbiamo mettere insieme i frammenti, come suggerisce Paola Parente. E costruire una rete vera, umana, che parte dalle persone.
Insegnanti, counselor e psicologi: il trio che può fare la differenza
Gli insegnanti sono la prima guida, quella che ci accompagna tutti i giorni in aula. Sempre più spesso seguono corsi specifici per diventare referenti per l’orientamento, e quando lo fanno bene diventano figure-ponte tra ciò che siamo e ciò che possiamo diventare.
I counselor entrano in gioco quando si tratta di esplorare risorse interiori, desideri, timori. Non danno risposte pronte, ma aiutano a formulare domande vere. A costruire un dialogo con se stessi. A scegliere, non solo a decidere.
Gli psicologi portano con sé strumenti scientifici: test, osservazioni, colloqui che aiutano a capire le inclinazioni, le emozioni, le difficoltà nascoste. Ma il loro ruolo, come sottolinea Parente, non si ferma al profilo individuale: sono sentinelle del sistema, capaci di cogliere dove l’organizzazione educativa sta fallendo nel prendersi cura.
Orientare non è un evento: è un processo
Quello che manca, spesso, è una visione integrata. Oggi — lo dice chiaramente Parente — l’orientamento è trattato in modo segmentato. C’è il progetto STEM da una parte, quello sulle soft skill dall’altra, il laboratorio creativo in un’altra aula ancora. I ragazzi e le ragazze vengono divisi a pezzetti. Ma l’orientamento vero non separa, riunisce.
In un mondo dove le macchine sono sempre più performanti, Parente ci ricorda che le persone restano insostituibili per una ragione chiara: l’apprendimento umano è fatto anche di ciò che non si codifica. Immagini, odori, atmosfere, relazioni. È lì che nascono due delle aree decisive per l’orientamento del futuro: la matematica e l’arte. Due linguaggi visivi, intuitivi, profondi. Due modi per imparare a pensare con immaginazione.
“Noi abbiamo un apprendimento non codificato. Entriamo in una stanza e impariamo dai colori, dagli odori. Le macchine non possono farlo. Noi sì.” — Paola Parente
Dove trovare aiuto? Nella scuola, ma non solo
Spesso la scuola è il primo punto di accesso. Open day, sportelli di ascolto, colloqui individuali: molte strutture offrono supporto gratuito grazie a insegnanti formati e professionisti interni. Ma esistono anche servizi esterni: centri pubblici, cooperative, realtà private, che mettono a disposizione test approfonditi e percorsi su misura.
Il punto, però, non è solo dove cercare, ma cosa cercare. Non un’indicazione precisa su “che lavoro fare”, ma un’alleanza educativa. Qualcuno che dica: “Puoi partire da qui, da quello che sei ora. Non da quello che manca”.
In conclusione: l’orientamento è politica culturale
L’orientamento non è un’appendice del sistema scolastico. È il cuore del problema educativo italiano. Come dice Parente, “i ragazzi non ce la fanno, ma non è colpa loro: è la nostra sconfitta. Gli abbiamo chiesto tutto: essere eccellenti, ecologisti, performanti. Ma non gli abbiamo lasciato tempo per immaginarsi”.
Ecco perché serve una nuova alleanza tra scuola, famiglie, professionisti e mondo del lavoro. Serve un progetto che non separi, ma connetta. Un progetto che metta le persone, finalmente, al centro.