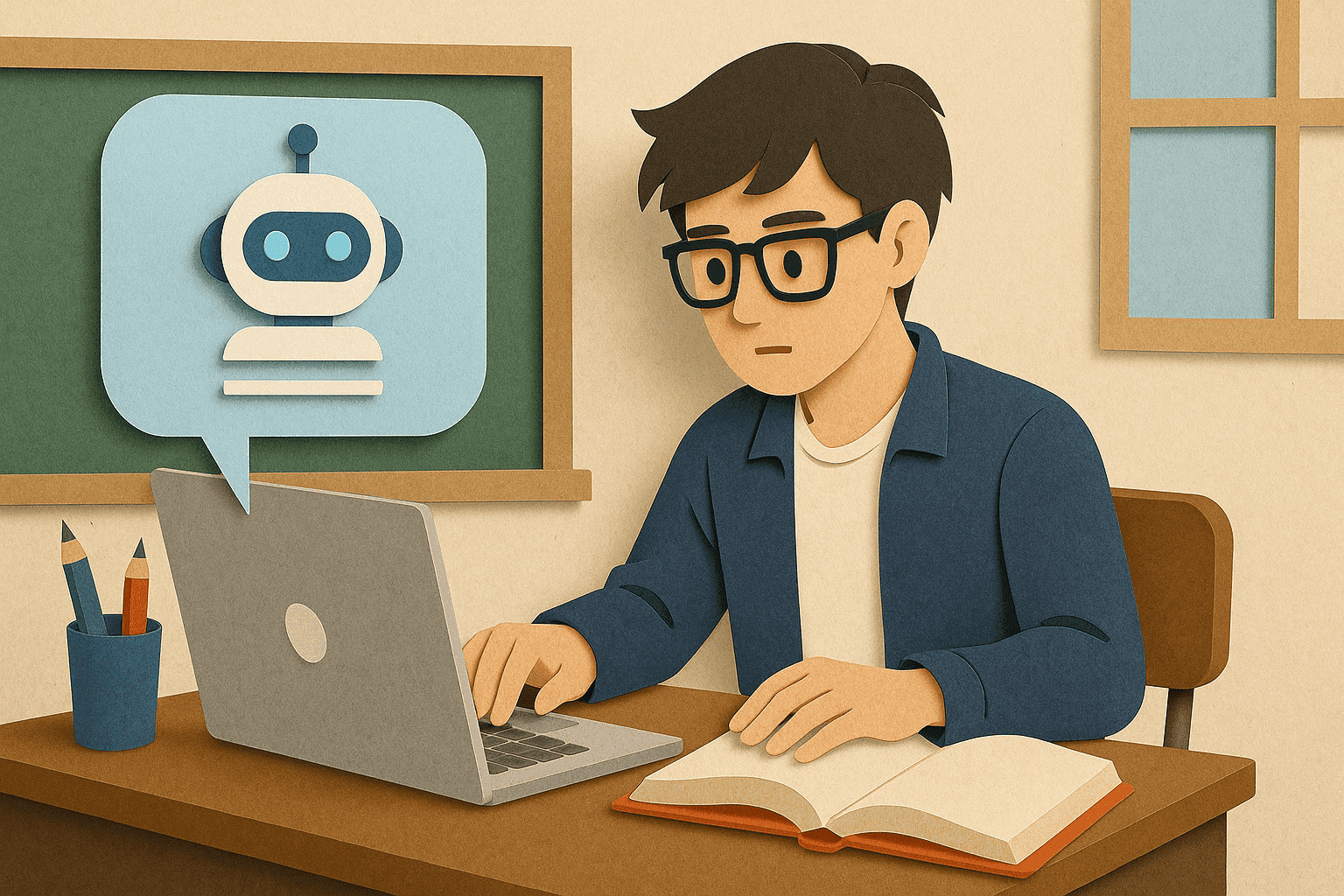Riuscire a portare a termine un compito, mantenere la concentrazione per tutta una lezione, organizzare il materiale senza distrarsi o alzarsi in continuazione: sono sfide quotidiane che molti bambini e ragazzi con ADHD (Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività) devono affrontare a scuola. In un contesto scolastico strutturato e ricco di stimoli, le difficoltà legate a disattenzione, impulsività e iperattività possono diventare ostacoli significativi, influenzando non solo il rendimento scolastico ma anche la partecipazione attiva e serena alla vita in classe.
Per questo è fondamentale che la scuola riconosca questi bisogni specifici e vi risponda in modo appropriato, offrendo un percorso personalizzato che tenga conto delle caratteristiche individuali. È in questa cornice che si inserisce il PDP – Piano Didattico Personalizzato, lo strumento educativo previsto per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES).
Cos’è l’ADHD e come si manifesta
L’ADHD è un disturbo del neurosviluppo che si presenta con livelli atipici di disattenzione, impulsività e iperattività, tali da compromettere il funzionamento quotidiano in più contesti, tra cui quello scolastico. Anche se per i manuali diagnostici si parla di disturbo, chi si occupa di ADHD preferisce definirla una condizione, un modo differente di funzionare rispetto alla maggioranza delle persone.
Come altri disturbi del neurosviluppo, come spettro autistico, distrassia e DSA, l’ADHD comporta un funzionamento cerebrale atipico, a causa del quale il bambino, indipendentemente dal suo livello di intelligenza, presenta delle difficoltà specifiche a svolgere compiti previsti per la sua età. I sintomi si manifestano prima dei 12 anni, anche se spesso diventano più evidenti con l’ingresso a scuola. Dal punto di vista clinico, l’ADHD si distingue in tre sottotipi:
- prevalentemente disattento: difficoltà a concentrarsi, facilità a distrarsi, tendenza a dimenticare materiali, perdere il filo del discorso, apparente “lentezza” o “svagatezza”.
- Prevalentemente iperattivo-impulsivo: agitazione motoria, difficoltà a restare seduti, interruzioni frequenti, scarsa attesa del turno, comportamenti impulsivi e reazioni istintive.
- Combinato: presenza significativa di sintomi sia di disattenzione che di iperattività/impulsività.
Pur mantendendo delle caratteristiche nucleari specifiche, l’ADHD si manifesta in modi diversi da persona a persona: ad esempio, gli alunni in cui è preponderante l’iperattività avranno difficoltà a stare seduti per molto tempo, le alunne ADHD in cui prevale la disattenzione faranno fatica a rimanere concentrate e gli studenti con una prevalenza impulsiva avranno la tendenza a interrompere le insegnanti o a disturbare i compagni. Non si tratta di un semplice problema comportamentale, ma di una condizione neurobiologica che incide concretamente sul funzionamento quotidiano dell’alunno, soprattutto in ambienti strutturati come la scuola. Se non gestita in modo adeguato, l’ADHD può diventare un problema per chi ne è affetto, per la famiglia, la scuola e la società.
Le manifestazioni del disturbo da deficit dell’attenzione variano molto in base all’età e al grado scolastico. Alla scuola primaria prevalgono spesso l’irrequietezza fisica, la difficoltà a rimanere al banco, la tendenza a interrompere la lezione, a disturbare i compagni o a dimenticare le consegne. Alla scuola secondaria di primo grado, il quadro può spostarsi verso una disorganizzazione crescente, problemi nella gestione del tempo e dello studio, conflitti relazionali. Alla scuola secondaria di secondo grado, le difficoltà si concentrano soprattutto sulle funzioni esecutive: pianificare, organizzare, portare a termine le attività in autonomia.
L’ADHD nelle ragazze: un disturbo ancora troppo invisibile
Uno degli aspetti meno noti ma più rilevanti dell’ADHD riguarda la sua differente espressione tra i generi. Le ragazze con ADHD, infatti, sono frequentemente sottodiagnosticate, e non perché il disturbo sia meno presente in termini epidemiologici, ma perché tende a manifestarsi in modo meno evidente rispetto ai coetanei maschi.
Nelle femmine, è più comune il sottotipo disattento: ciò significa che, invece di correre o parlare a voce alta, possono apparire semplicemente “distratte”, “sulle nuvole”, “poco motivate”. Non creano problemi evidenti in classe, quindi raramente attirano l’attenzione degli adulti. A ciò si aggiunge un fattore culturale: stereotipi ancora presenti portano a interpretare diversamente lo stesso comportamento a seconda che venga messo in atto da un maschio o da una femmina. L’irrequietezza degli alunni è considerata quasi fisiologica, a differenza della stessa irrequietezza delle alunne, che magari si manifesta in altri modi e che viene giudicata fuori luogo.
Diversi studi – tra cui le metanalisi pubblicate su Journal of Attention Disorders e le sintesi disponibili sul sito dell’Istituto Superiore di Sanità – confermano che le ragazze ricevono una diagnosi più tardi, con un maggiore rischio di sviluppare comorbidità come ansia, depressione, disturbi dell’umore e problemi relazionali. Per questo è fondamentale che la scuola sia in grado di riconoscere anche i segnali meno eclatanti e si interroghi su eventuali bias osservativi.
PDP, PEI, PEP: quale strumento per quale situazione?
In ambito scolastico, è utile distinguere tra i diversi strumenti di personalizzazione dell’insegnamento previsti dalla normativa:
• Il PDP (Piano Didattico Personalizzato) è pensato per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES). È lo strumento di riferimento per chi ha una diagnosi di ADHD, ma anche per studenti con DSA, svantaggio linguistico, situazioni emotive complesse o altre difficoltà non riconducibili a disabilità.
• Il PEI (Piano Educativo Individualizzato) è invece previsto per gli alunni con certificazione ai sensi della Legge 104/92. È obbligatorio e viene redatto dal Gruppo di Lavoro Operativo, con il coinvolgimento dell’insegnante di sostegno.
• Il PEP (Piano Educativo Personalizzato) è talvolta utilizzato in situazioni di disagio socio-culturale, ma non ha una normativa unitaria come PDP e PEI.
Per l’ADHD, quindi, il PDP è lo strumento più adeguato, anche in assenza di un insegnante di sostegno. Può essere attivato sulla base di una diagnosi rilasciata dal Servizio Sanitario Nazionale o da strutture accreditate.
Attivazione e contenuti di un PDP
Il PDP viene redatto dal consiglio di classe o dal team docente, in collaborazione con la famiglia e con eventuali specialisti. La scuola può proporlo autonomamente, oppure su richiesta della famiglia al momento della presentazione della diagnosi. Il documento dovrebbe essere predisposto entro il primo trimestre dell’anno scolastico, ma può essere attivato in qualsiasi momento in caso di nuove esigenze.
Un PDP efficace deve contenere una descrizione dettagliata delle caratteristiche dell’alunno, gli obiettivi da raggiungere, le strategie didattiche da adottare, gli strumenti compensativi (mappe concettuali, sintesi vocale, audiolezioni, timer, pc) e le misure dispensative (tempi aggiuntivi, esonero da alcune attività, interrogazioni orali al posto delle verifiche scritte). È importante che il documento specifichi anche i criteri di valutazione, che devono essere coerenti con il percorso personalizzato. L’obiettivo non è semplificare i contenuti, ma rendere accessibile l’apprendimento.
Strategie didattiche per alunni con ADHD: cosa può fare concretamente un insegnante
Un PDP efficace non si limita a elencare misure generiche, ma individua soluzioni concrete e personalizzate. Per un alunno con ADHD, le strategie didattiche da adottare possono fare la differenza tra frustrazione e successo. Alcuni esempi pratici includono:
- scomporre i compiti complessi in fasi più brevi e guidate ;
- prevedere pause frequenti e regolari, per evitare il sovraccarico cognitivo ;
- offrire istruzioni semplici e chiare, possibilmente scritte e ripetute oralmente ;
- permettere l’uso di strumenti digitali (timer visivi, mappe concettuali, sintesi vocale) ;
- scegliere modalità di interrogazione più flessibili, come la programmazione anticipata o l’orale al posto dello scritto ;
- evitare confronti tra compagni, valorizzando il progresso individuale .
Anche l’ambiente può essere adattato: ad esempio, scegliendo una postazione lontana da fonti di distrazione o vicino al docente, per facilitare un monitoraggio discreto. Piccoli accorgimenti, applicati con coerenza, possono migliorare l’esperienza scolastica.
ADHD non riconosciuto: le conseguenze scolastiche e psicologiche
Quando l’ADHD non viene riconosciuto e supportato in modo adeguato, le conseguenze possono estendersi ben oltre le difficoltà scolastiche. Molti ragazzi, soprattutto durante le scuole medie e superiori, iniziano a sperimentare senso di frustrazione, bassa autostima, ritiro sociale, fino ad arrivare, nei casi più gravi, a sintomi ansiosi o depressivi.
Spesso si innesca un circolo vizioso: le difficoltà non comprese vengono interpretate come scarso impegno, svogliatezza o ribellione. Questo porta a richiami, voti bassi e un progressivo disinvestimento da parte dello studente. Una diagnosi tempestiva e un PDP costruito in modo realistico e collaborativo aiutano non solo a migliorare il rendimento scolastico, ma anche a contenere il rischio di ricadute psicologiche, rafforzando la percezione di essere compresi e sostenuti.
Come si ottiene una diagnosi di ADHD valida per la scuola?
Per attivare un PDP, è necessario che l’ADHD sia stato diagnosticato da un ente accreditato. La valutazione deve provenire dai servizi pubblici del Sistema Sanitario Nazionale (ad esempio neuropsichiatria infantile e ambulatori ADHD) o strutture private accreditate, cioè riconosciute dalla Regione. La diagnosi deve essere redatta da uno specialista (neuropsichiatra infantile o psicologa), specificare chiaramente il disturbo secondo i criteri internazionali e possibilmente includere indicazioni operative utili per la scuola. Va tuttavia considerato che molte scuole richiedono esclusivamente la diagnosi del SSN, e non quella di un ente privato, per poter redarre il PDP o per offrire l’insegnante di sostegno, qualora si ritenga necessario un supporto per l’alunno e la classe. È importante, quindi, prima di intraprendere un percorso diagnostico, valutare con attenzione a quale struttura – se privata o pubblica – e a quali specialisti affidarsi.
Famiglie e insegnanti che sospettano un funzionamento ADHD possono rivolgersi al pediatra o al medico di base, che potrà indicare il percorso diagnostico più appropriato. Alcune scuole, inoltre, offrono sportelli di ascolto o supporto psicopedagogico per un primo orientamento. L’inclusione non è una dichiarazione d’intenti: è un impegno quotidiano, fatto di strumenti concreti, alleanze educative e uno sguardo che tenga conto delle diversità. Il PDP, se ben strutturato, può fare la differenza per uno studente con ADHD. Non solo sul piano didattico, ma anche nel vissuto scolastico complessivo.
Accogliere i bisogni, anche quelli meno visibili, significa riconoscere che non tutti imparano allo stesso modo, ma che tutti hanno diritto a imparare. E questa, più che una procedura, è una questione di cultura.