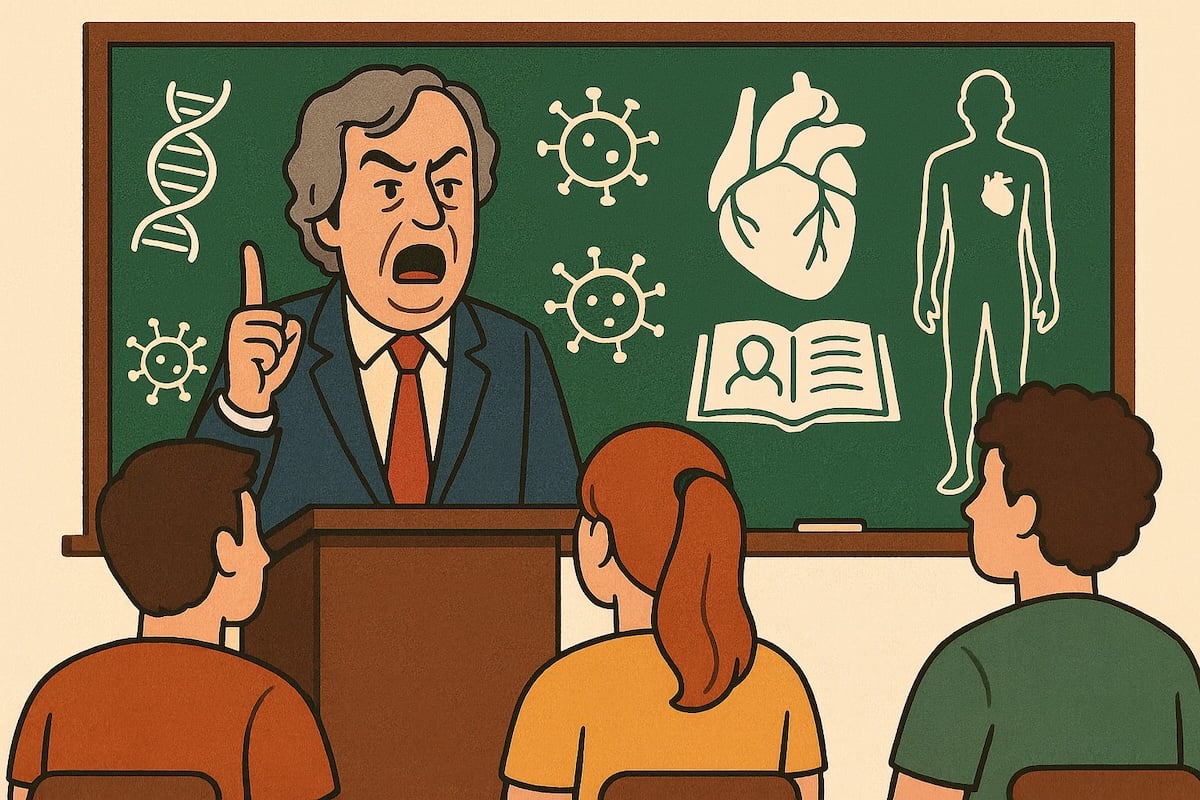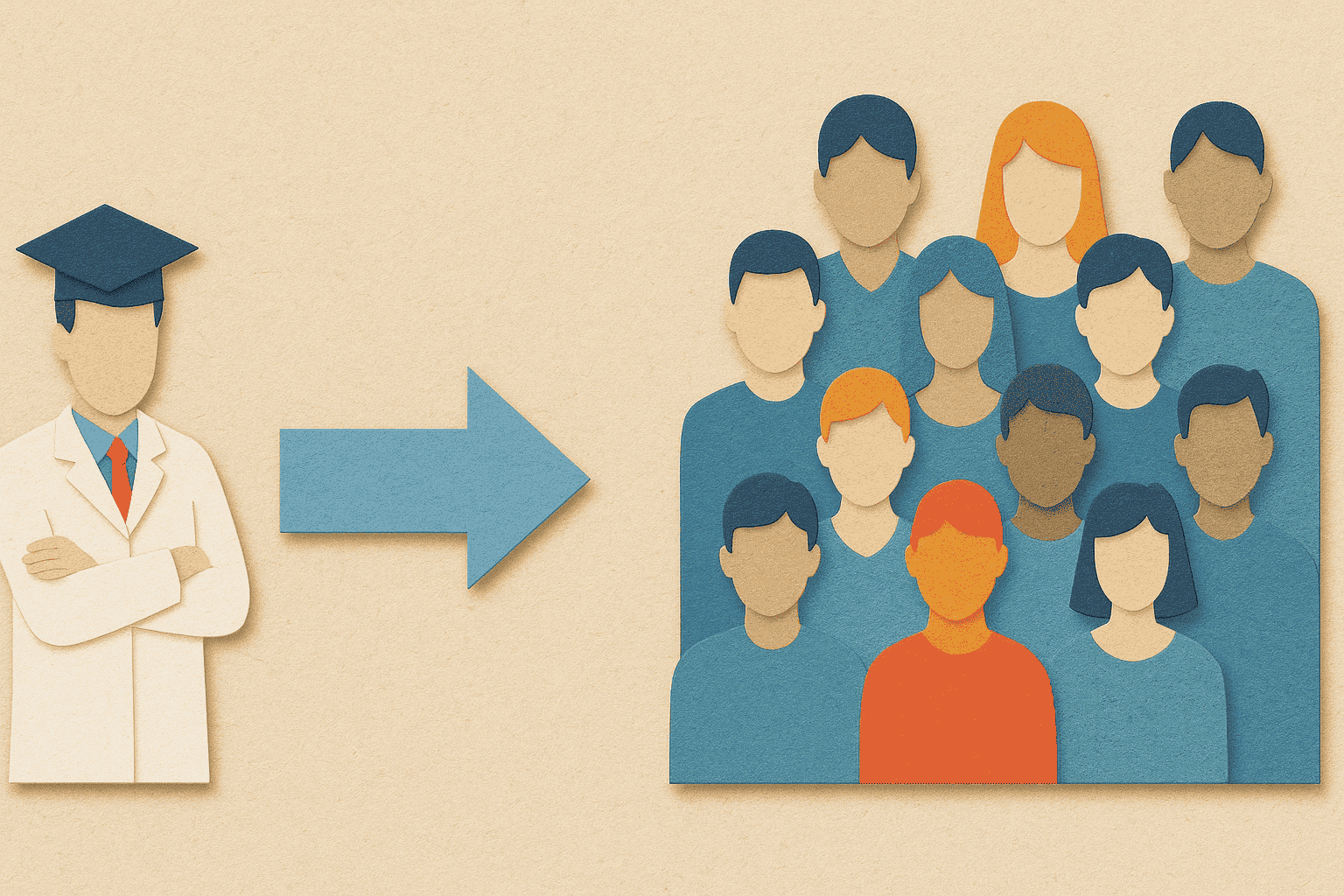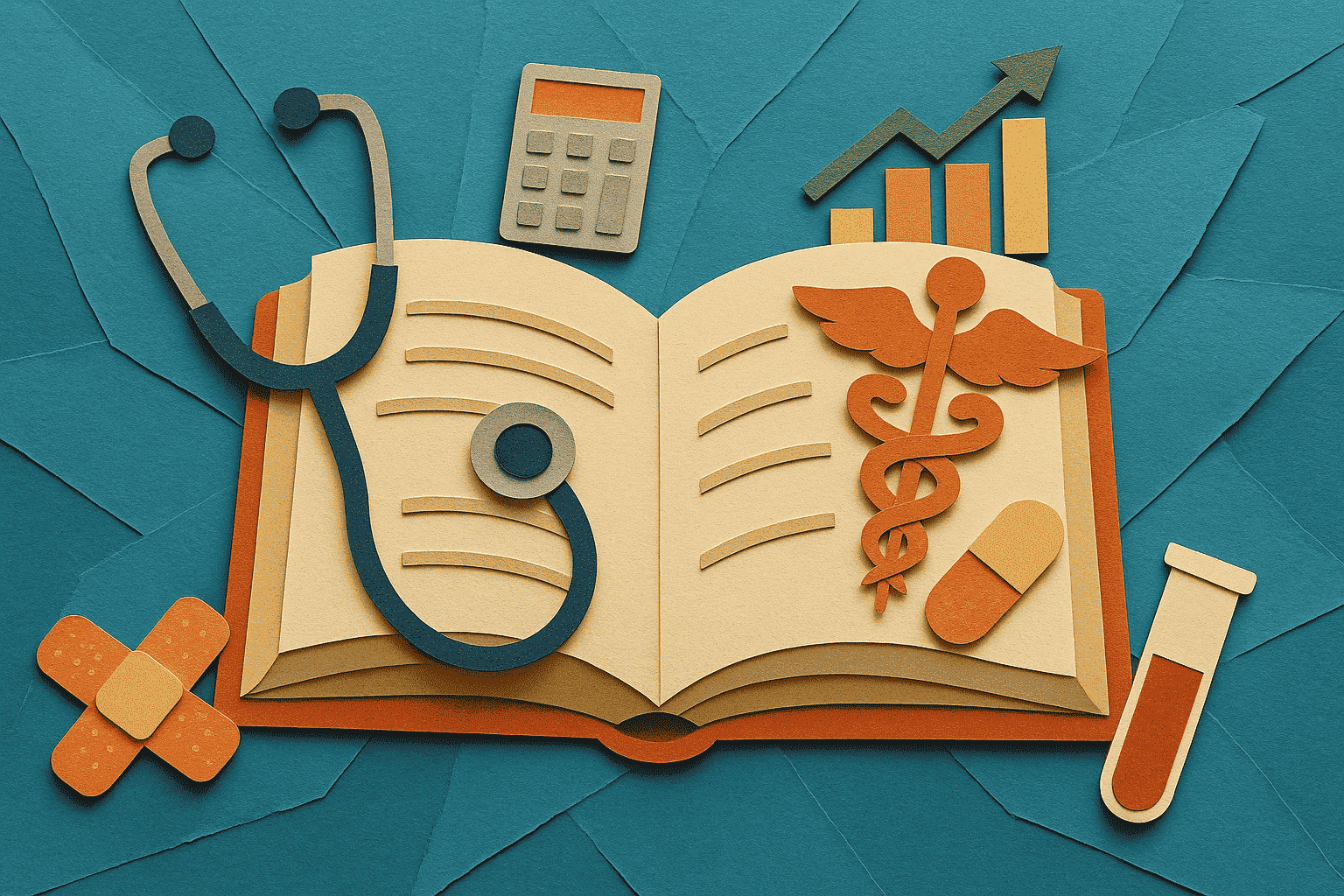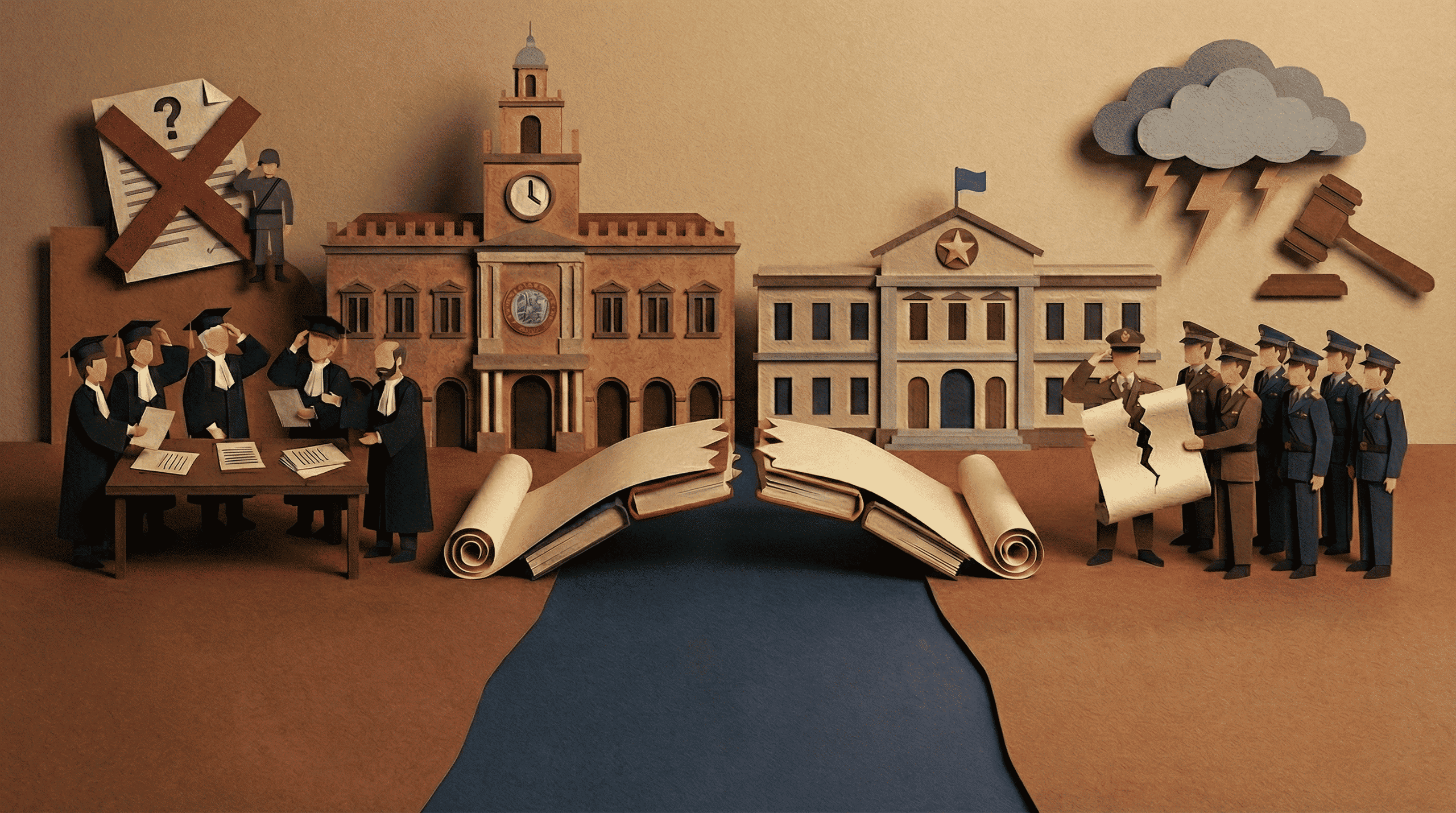AGGIORNAMENTO DEL 10 NOVEMBRE 2025
La Lega ha ritirato l’emendamento che prevedeva il divieto assoluto di educazione sessuale e affettiva anche nelle scuole medie. Nella nuova versione del disegno di legge Valditara, le attività su questi temi saranno ammesse alle medie, ma solo se i genitori daranno il proprio consenso informato scritto. Non si tratta quindi di un’apertura totale, ma di un allineamento al modello già previsto per le superiori. Resta invece confermato il divieto per infanzia e primaria. Per maggiori dettagli, leggi l’articolo disponibile qui.
Il disegno di legge Valditara
In Italia si è acceso un dibattito acceso e polarizzato sull’educazione sessuale nelle scuole, dopo che il governo ha promosso un provvedimento che restringe fortemente lo spazio per trattare i temi della sessualità e dell’affettività nel percorso scolastico.
Tutto nasce da un emendamento approvato qualche giorno fa in Commissione Cultura alla Camera, nell’ambito del disegno di legge sul “consenso informato in ambito scolastico” presentato dal ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara.
Il ministro ha più volte negato che si tratti di un divieto, sostenendo che l’educazione sessuale “in senso biologico” resterà garantita nei programmi e che il suo obiettivo è “evitare indottrinamenti e teorie gender” nelle scuole, ma opposizioni, esperti, docenti e associazioni denunciano un arretramento culturale, con il rischio di cancellare ogni forma di educazione all’affettività proprio in un momento in cui violenza di genere, pornografia online e disinformazione richiederebbero strumenti educativi più solidi. Per capire cosa sta succedendo, occorre guardare cosa prevede la nuova normativa, come la giustifica il ministro, perché tanti la criticano, e come funziona l’educazione sessuale nel resto d’Europa.
Cosa prevede il nuovo disegno di legge
Il DDL Valditara introduce una serie di novità che, di fatto, limitano fortemente le iniziative extra-curriculari sulle tematiche sessuali e affettive nelle scuole italiane.
1. Consenso informato obbligatorio
Le scuole dovranno ottenere un consenso informato scritto e preventivo dei genitori (o degli studenti se maggiorenni) prima di svolgere qualsiasi attività che tratti temi legati alla sessualità. I genitori dovranno essere informati in modo dettagliato su obiettivi, contenuti, materiali e qualifiche degli eventuali esperti esterni coinvolti. Chi non dà il consenso esclude automaticamente il figlio dall’attività, che sarà sostituita con proposte alternative.
2. Divieto per infanzia, elementari e medie
Il testo originale del disegno di legge già prevedeva l’esclusione di ogni attività dedicata alla sessualità nelle scuole dell’infanzia e nelle primarie. Con l’emendamento approvato in Commissione, il divieto è stato esteso anche alle scuole medie. Questo significa che, in questi gradi scolastici, non si potranno organizzare corsi, incontri o laboratori specificamente dedicati a temi come affettività, prevenzione, identità di genere o sessualità, neppure se a proporli fossero enti pubblici o sanitari.
3. Restrizioni alle superiori
Alle scuole superiori, dove non c’è divieto assoluto, ogni progetto di educazione sessuale o affettiva dovrà essere sottoposto a un iter complesso: valutazione e approvazione del collegio docenti e del consiglio d’istituto; informativa dettagliata alle famiglie; consenso scritto da parte dei genitori; selezione di esperti esterni sulla base di criteri di “competenza, trasparenza e adeguatezza”. Di fatto, l’autonomia scolastica che finora permetteva a molti istituti di collaborare con le ASL, i consultori o associazioni qualificate viene fortemente ridimensionata.
4. Eccezioni limitate
Il provvedimento precisa che il divieto “si applica nel rispetto delle Indicazioni nazionali per il curricolo”. Le Indicazioni nazionali già oggi includono – all’interno dei programmi di scienze – obiettivi minimi come: “acquisire le prime informazioni su riproduzione e sessualità” (fine della primaria); “acquisire corrette informazioni sullo sviluppo puberale e la sessualità” (fine della terza media). Nella bozza di aggiornamento 2025, il ministero ha aggiunto l’obiettivo di “conoscere i rischi delle malattie sessualmente trasmissibili”. Questi temi continueranno quindi a essere trattati, ma solo in chiave biologica e limitata. Tutto ciò che va oltre – relazioni, consenso, emozioni, orientamento, rispetto – verrà escluso alle medie e alle elementari, e filtrato alle superiori tramite il meccanismo del consenso.
La posizione del ministro Valditara
In un’intervista a La Stampa del 19 ottobre 2025, Valditara ha difeso la riforma, sostenendo che l’educazione sessuale non viene abolita, ma “ripulita” da ideologie. “L’educazione sessuale resta, ma no a teorie gender e indottrinamenti”, ha dichiarato. Per il ministro, si continuerà a studiare “le differenze sessuali fra maschio e femmina, la riproduzione, la pubertà e la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili”, ma non dovranno entrare nelle aule “teorie complesse sull’identità di genere” che, a suo dire, “non sono comprensibili per i bambini e creano confusione”.
Il consenso informato – ha spiegato – serve proprio “a evitare che i bambini si trovino davanti a tematiche non adatte alla loro età”. Valditara ha poi attaccato le opposizioni per aver “strumentalizzato il tema dei femminicidi”, ribadendo che il governo non è contro l’educazione al rispetto ma “contro gli abusi ideologici nelle scuole”. Il ministro cita anche alcuni risultati: i corsi sperimentali di educazione al rispetto avviati nel 2024 avrebbero, secondo un questionario ministeriale, “migliorato i comportamenti dei ragazzi nel 70% dei casi”.
Ha inoltre indicato tra le priorità la lotta alla pornografia online, definendola “una delle cause principali di una visione distorta della sessualità e dei rapporti”. Infine, ha sottolineato che il governo ha già attivato, tramite INDIRE, corsi di formazione per docenti dedicati all’educazione alle relazioni, all’empatia e al rispetto, e che “la prevenzione dei femminicidi passa da lì, non dalle lezioni di sesso”.
Cosa c’è di vero e cosa no
Molte affermazioni del ministro, però, non reggono alla verifica dei fatti.
Non è vero che non ci siano divieti: il disegno di legge vieta espressamente ogni attività progettuale su temi di sessualità e affettività in infanzia, primaria e medie, lasciando solo quanto già incluso nei programmi di scienze. Parlare quindi di “educazione sessuale che resta” è tecnicamente vero solo in parte: ciò che resta è un approccio biologico e minimale, non un’educazione integrata alla persona.
Il consenso informato non è una prassi comune in Europa. In quasi tutti i Paesi europei l’educazione sessuale è parte del curriculum obbligatorio, e i genitori non devono firmare un consenso scritto per consentire la partecipazione dei figli.
La regola europea è semmai l’opposto: opt-out (si può chiedere di non partecipare), non opt-in (si partecipa solo se si autorizza). Il richiamo ai “dati” del 70% è un’auto-valutazione interna, senza metodologia pubblica né validazione indipendente. Non esistono al momento studi che provino un impatto misurabile dei corsi ministeriali su larga scala. Il riferimento ai Paesi nordici è fuorviante.
Valditara ha sostenuto che nei Paesi con più educazione sessuale ci sarebbero anche alti tassi di violenze, ma i dati internazionali mostrano che la Comprehensive Sexuality Education (CSE), sostenuta da OMS e UNESCO, migliora la salute sessuale e relazionale, riduce gravidanze precoci e aumenta il rispetto reciproco. Il nesso diretto con i femminicidi è complesso, ma non esistono evidenze che la CSE aumenti la violenza: semmai il contrario.
Le critiche dell’opposizione e degli esperti
Le opposizioni parlamentari hanno definito il provvedimento un grave arretramento culturale. Irene Manzi, responsabile scuola del PD, ha parlato di una “risposta sbagliata a un’emergenza reale”: mentre il Paese è scosso da femminicidi e violenze di genere, “la destra sceglie di vietare l’educazione all’affettività e al rispetto”.
Alessandro Zan ha commentato che “così l’Italia torna al Medioevo”. Elisabetta Piccolotti (Alleanza Verdi e Sinistra) ha denunciato una “deriva oscurantista ispirata dal fondamentalismo religioso”. Secondo Antonio Caso (M5S), vietare percorsi educativi che aiutano i giovani a conoscere se stessi “significa lasciarli al buio dell’ignoranza”. Molti esperti condividono la preoccupazione.
La presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine degli Psicologi, Maria Antonietta Gulino, ha scritto che vietare l’educazione sessuale o affettiva “è un ostacolo allo sviluppo relazionale e alla salute psicologica”. Senza spazi sicuri e guidati da professionisti, i ragazzi si formano su Internet, dove trovano pornografia, modelli distorti e disinformazione.
Sondaggi recenti confermano il paradosso: quasi l’80% dei genitori e l’89% degli adolescenti vorrebbero corsi strutturati di educazione sessuale a scuola; solo il 47% degli studenti italiani ha mai partecipato a un’attività di questo tipo; tra gli 11 e i 13 anni, oltre il 40% non ha mai usato il preservativo nei primi rapporti; più della metà dei giovani dice di non parlare mai di sesso o contraccezione in famiglia. Numeri che mostrano una domanda sociale forte e una risposta istituzionale debole.
Come funziona nel resto d’Europa
Nel resto d’Europa la direzione è esattamente opposta. La Commissione Europea e l’OMS Europa promuovono da anni la già citata Comprehensive Sexuality Education (CSE) come strumento di salute pubblica e di prevenzione sociale. In quasi tutti i Paesi europei l’educazione sessuale è obbligatoria e integrata nei programmi scolastici. Non è un modulo facoltativo, ma un insieme di conoscenze e competenze legate a corpo, relazioni, consenso, identità e salute. In genere, si insegna dalla scuola primaria in modo graduale e scientificamente fondato. I
l coinvolgimento dei genitori è previsto, ma a livello informativo, non attraverso un consenso scritto. In Germania, Francia, Paesi Bassi, Spagna, Portogallo e Svezia, i genitori vengono informati sui contenuti, ma non devono autorizzare ogni attività: il principio è che l’educazione sessuale sia parte del diritto all’istruzione. In Francia i corsi sono obbligatori dal 2001, con almeno tre sessioni l’anno per ogni livello scolastico.
In Germania l’approccio è obbligatorio in tutti i Länder, con equilibrio tra diritti educativi dei genitori e dovere dello Stato di garantire istruzione scientifica. Nei Paesi Bassi si inizia già a 6 anni, con focus su emozioni, consenso, rispetto e diversità. In Spagna, dal 2022, l’educazione affettivo-sessuale è inserita nel curriculum nazionale. Solo pochi Paesi (tra cui Polonia e Ungheria) hanno introdotto limitazioni simili a quelle italiane, chiedendo il consenso esplicito dei genitori o restringendo i temi trattabili. In questi casi la partecipazione è crollata e le organizzazioni internazionali hanno segnalato il rischio di disuguaglianze formative.
Il “consenso scritto” richiesto dal DDL Valditara rappresenta quindi un’anomalia nel panorama europeo: non esiste come prassi sistemica nei Paesi che garantiscono un’educazione sessuale curricolare. Dove compare, riguarda attività aggiuntive, non l’insegnamento ordinario. In sostanza, l’Italia si isolerebbe rispetto agli standard educativi europei, introducendo un modello che rischia di escludere proprio chi avrebbe più bisogno di partecipare.
Una frattura culturale
La vicenda dell’educazione sessuale mostra una frattura profonda tra due visioni: da un lato, chi considera la scuola un luogo per formare persone consapevoli, capaci di vivere relazioni sane e rispettose; dall’altro, chi ritiene che certi temi debbano restare competenza esclusiva della famiglia. Il governo di destra ha scelto chiaramente la seconda strada, imponendo filtri e divieti in nome della tutela dei minori e del ruolo educativo dei genitori. I sostenitori del DDL parlano di “buon senso” e di “protezione dell’infanzia”; i detrattori vedono un ritorno all’ignoranza come forma di controllo. In un Paese dove il dibattito su sessualità, genere e affettività resta fragile, la scuola rischia di diventare il terreno di uno scontro ideologico più che un luogo di crescita.
L’educazione sessuale non è una lezione di anatomia, ma una forma di orientamento alla vita: significa imparare a conoscersi, rispettarsi, proteggersi e riconoscere gli altri. Oggi, con l’esplosione della pornografia online, il cyberbullismo e la violenza di genere, spegnere questi temi a scuola equivale a lasciare i giovani soli nel buio.
In Europa, le esperienze più avanzate mostrano che un’educazione sessuale scientifica, laica e rispettosa non minaccia i valori familiari: li rafforza, perché aiuta genitori e figli a comunicare meglio.
L’Italia, scegliendo la via del consenso preventivo e del divieto per i più giovani, rischia di allontanarsi dagli standard internazionali e di privare una generazione di strumenti fondamentali per crescere in modo libero, sano e consapevole. Un’educazione sessuale ben fatta non è un pericolo. È un atto di fiducia nella conoscenza, nella maturità e nella dignità dei ragazzi e delle ragazze.